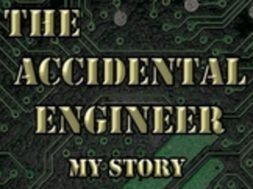(di Nicola Facciolini) – “Così sarà anche alla venuta del Figlio dell’uomo. Allora due uomini saranno nel campo: uno sarà preso e l’altro lasciato. Due donne macineranno alla mola: una sarà presa e l’altra lasciata”(Vangelo di Gesù Cristo secondo Matteo 24,39-41). “Segnali di vita nei cortili e nelle case all’imbrunire, le luci fanno ricordare le meccaniche celesti” (Franco Battiato). Gli esopianeti alieni ufficialmente scoperti nella nostra Galassia provano, al di là di ogni ragionevole dubbio, che gli esomondi extraterrestri come la Terra sono più comuni di quanto si creda, tra le 400 miliardi di stelle della Via Lattea, in attesa dell’arrivo su Plutone della sonda New Horizons il 14 Luglio 2015. La rilevazione della prima Terra Nova extrasolare, del tutto simile al nostro Mondo per composizione chimico-fisica, è solo questione di mesi. Miliardi di stelle nella nostra Galassia possono avere da uno a tre pianeti abitabili nella loro zona Riccioli d’Oro, anche nei sistemi solari multipli, dotati cioè di più astri, magari di diverso colore. “Non siamo destinati a salvare il mondo, siamo destinati ad abbandonarlo”, è la morale del colossal Interstellar di Christopher Nolan. Ma non c’è ragione di crederlo se la Scienza e la Tecnologia finalmente libere anche nell’Italia patria di Enrico Fermi e Ettore Majorana, potranno riversare sull’Umanità i preziosi frutti della Ricerca Nucleare evidentemente assenti nella godereccia maccheronica Esposizione Universale di Milano Expo2015, trent’anni dopo il famigerato referendum anti-nucleare (legislazione negativa ordinaria a quanto pare più vincolante del Referendum costituzionale che nel 2008 ha già bocciato le controriforme oggi riproposte sotto le mentite spoglie ordinarie dell’Italicum di Renzusconi!) che ha condannato il Belpaese alla crisi perenne e alla fine della Democrazia.
L’Italia dove le solenni “invenzioni” si riducono, per la felicità degli Alieni magari forse anche curiosi della nostra cucina mediterranea, a maccheroni, tarallucci e vino, dispone di cervelli molto più intelligenti del team di Big Bang Theory! Grazie alla liberalizzazione dell’impresa e dell’industria spaziale privata, possiamo conquistare il Cosmo già ora, se lo desideriamo, se cioè investiamo nel Futuro i trilioni di euro destinati ai Warlords. Se c’è una morale dell’Expo2015 da apprendere con somma urgenza è che, come Italiani, non siamo nè prigionieri nè schiavi nè servi dell’inevitabile autodistruzione dei mercati “derivati” che invocano una Terza Guerra Mondiale! Questa è anche la morale della Scienza galileiana come sembrano suggerire gli studi di Kip Thorne e Leonard Susskind su Buchi Neri e Supermateria, fedeli alla Lezione di Star Trek incarnata dal vulcaniano Spock (Leonard Nimoy). È con il medesimo spirito libero che astronomi dell’Osservatorio Europeo Australe (ESO), grazie al “cacciatore” multispettrale di pianeti alieni HARPS, installato sul telescopio da 3,6 metri dell’Osservatorio di La Silla in Cile, hanno rilevato per la prima volta in modo diretto la luce visibile riflessa dal primo pianeta extrasolare osservato dalla faccia della Terra. Le osservazioni hanno anche svelato nuove proprietà di quest’oggetto famoso, il primo esomondo rilevato intorno a una stella normale, 51 Pegasi-b. Il risultato promette un radioso futuro con l’avvento di strumenti di nuova generazione, come EXPRESSO sul Very Large Telescope, e rivelatori simili accoppiati al magnifico E-ELT. L’esopianeta 51 Pegasi-b, si trova a circa 50 anni luce dalla Terra nella costellazione di Pegaso. L’esomondo e la sua stella madre sono tra gli oggetti che attendono un nome scientificamente valido dal concorso pubblico NameExoWorlds (“Dai un nome ai pianeti extrasolari”) dell’International Astronomical Union. È stato scoperto nel 1995 e verrà sempre ricordato come il primo pianeta extrasolare confermato in orbita intorno a una stella, non proprio comune là fuori, come il Sole. Anche se, a ragion del vero, due oggetti planetari furono osservati in precedenza nell’ambiente estremo di una Pulsar. L’esopianeta 51 Pegasi-b, viene considerato come il tipico “Giove caldo”, una classe di pianeti extrasolari ormai ritenuta comune, simile in dimensione e massa al nostro Giove, ma con un’orbita molto più vicina alla stella madre. Dal momento della storica scoperta sono stati confermati più di 1900 esopianeti in 1200 sistemi planetari alieni. E nel ventesimo anniversario della scoperta, 51 Pegasi-b torna sotto i riflettori mondiali per mostrare un nuovo progresso nello studio degli esopianeti. L’equipe, guidata da Jorge Martins dell’Istituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA) e dell’Universidade do Porto (Portogallo) al momento studente di Dottorato all’ESO in Cile, è composta da: N.C. Santos (IA e Universidade do Porto), P. Figueira (IA e Universidade do Porto), J.P. Faria (IA e Universidade do Porto), M. Montalto (IA e Universidade do Porto), I. Boisse (Aix Marseille Université, Marseille, Francia), D. Ehrenreich (Observatoire de Genève, Geneva, Svizzera), C. Lovis (Observatoire de Genève), M. Mayor (Observatoire de Genève), C. Melo (ESO, Santiago, Cile), F. Pepe (Observatoire de Genève), S.G. Sousa (IA e Universidade do Porto), S. Udry (Observatoire de Genève) e D. Cunha (IA e Universidade do Porto). Attualmente il metodo più diffusamente impiegato per esaminare l’atmosfera dell’esopianeta è di osservare lo spettro della stella madre filtrato attraverso i gas atmosferici del pianeta durante il transito, una tecnica nota come spettroscopia in trasmissione. Un approccio alternativo è quello di osservare il sistema quando la stella passa di fronte al pianeta, cosa che fornisce soprattutto informazioni sulla temperatura dell’esomondo.
La nuova tecnica non richiede un transito planetario e perciò può potenzialmente essere usata per studiare molti più pianeti extrasolari, permettendo di rilevare direttamente lo spettro dell’esomondo in luce visibile. Il che significa che si possono dedurre le diverse caratteristiche del pianeta, inaccessibili con altre tecniche. Lo spettro della stella madre viene usato come modello per la ricerca di un’impronta di luce simile che dovrebbe essere riflessa dall’esopianeta durante l’orbita. Un compito estremamente difficile poichè i pianeti sono veramente deboli rispetto alle stelle madri abbaglianti. Il segnale proveniente dal pianeta viene anche sommerso facilmente da altri effetti molto piccoli e da varie sorgenti di rumore. “Questo tipo di tecnica di rivelazione è di grande importanza scientifica – rivela Jorge Martins – poichè permette di misurare la reale massa del pianeta e l’inclinazione della sua orbita, che è essenziale per una comprensione completa del sistema. Permette inoltre di stimare la riflettività del pianeta, o albedo, che può essere usata per dedurre la composizione della superficie e dell’atmosfera del pianeta”. L’esomondo 51 Pegasi-b, ha una massa circa la metà di quella di Giove e un’orbita con un’inclinazione di circa nove gradi rispetto alla direzione della Terra. Ciò significa che l’orbita dell’esopianeta appare quasi di taglio, vista da Terra, anche se non abbastanza per dare luogo a un transito. L’oggetto altamente riflettente sembra anche avere un diametro maggiore di quello di Giove. Queste sono proprietà tipiche di un “Giove caldo”, molto vicino alla sua stella madre, esposto a una luce stellare intensa. HARPS è stato fondamentale per il lavoro dell’equipe presentato nell’articolo “Evidence for a spectroscopic direct detection of reflected light from 51 Peg b”, di J. Martins et al., pubblicato dalla rivista Astronomy & Astrophysics. Il risultato ottenuto da un telescopio di 3,6 metri di diametro, con una gamma limitata di applicazioni, è la vera notizia entusiasmante per gli astronomi. Le attrezzature esistenti, come questa, saranno presto aggiornate da strumenti più avanzati accoppiati a telescopi più grandi, come il VLT e l’European Extremely Large Telescope. ESPRESSO sul VLT e successivamente strumenti sempre più potenti, permetteranno un aumento significativo della precisione nell’area di raccolta dei fotoni, favorendo il rilevamento di esopianeti più piccoli, magari come la Terra, aumentando il livello di dettaglio dei dati per gli esomondi simili a 51 Pegasi-b. “Stiamo aspettando con ansia la prima luce di ESPRESSO, lo spettrografo del VLT – confessa Nuno Santos dell’IA e dell’Universidade do Porto, co-autore del nuovo articolo – così da poter fare studi più dettagliati di questo su altri sistemi planetari”. Altri astronomi dell’Eso per la prima volta hanno scoperto la presenza di molecole organiche complesse, i mattoni della vita, in un disco protoplanetario che circonda una giovane stella. Lo studio, realizzato grazie all’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array, riconferma che le condizioni necessarie all’origine della Terra e del Sole non sono uniche nell’Universo. I risultati sono pubblicati sulla rivista Nature.
Le nuove osservazioni di Alma rivelano l’esatta composizione del disco protoplanetario che circonda la giovane stella MWC 480, saturo di cianuro di metile (CH3CN), una molecola complessa a base di carbonio. Intorno a MWC 480 si trova abbastanza cianuro di metile per riempire tutti gli oceani della Terra. La stella ha solo un milione di anni, secondo il catalogo di Mount Wilson, con righe brillanti di idrogeno nello spettro. Sia la molecola di cianuro di metile sia la sua cugina più semplice, l’acido cianidrico (HCN) sono stati trovati nelle zone esterne e gelide del disco appena formato, nella regione che gli astronomi ritengono analoga alla Fascia di Kuiper, il regno dei planetesimi ghiacciati e delle comete nel nostro Sistema Solare, oltre Nettuno. Le comete mantengono l’impronta incontaminata della chimica primitiva del Sistema Solare letteralmente cristallizzando il periodo della formazione planetaria. Si pensa che comete e asteroidi dalle zone esterne del Sistema Solare abbiano portato sulla giovane Terra l’acqua e le molecole organiche, aiutando a porre le basi per lo sviluppo della vita primordiale, la cui “scintilla” resta per ora ignota alla Scienza. “Studi di comete e asteroidi mostrano che la nebulosa che ha dato origine al Sole e ai pianeti era ricca di acqua e composti organici complessi”, osserva Karin Öberg, astronoma all’Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics a Cambridge (Massachussetts, Usa), prima autrice dell’articolo intitolato “The Cometary Composition of a Protoplanetary Disk as Revealed by Complex Cyanides” di K.I. Öberg et al., pubblicato sulla rivista Nature. Il team è composto da: Viviana V. Guzmán (Harvard-Smithsonian Centre for Astrophysics), Kenji Furuya (Leiden Observatory, Leiden University, Leiden, Paesi Bassi), Chunhua Qi (Harvard-Smithsonian Centre for Astrophysics), Yuri Aikawa (Kobe University, Kobe, Giappone), Sean M. Andrews (Harvard-Smithsonian Centre for Astrophysics), Ryan Loomis (Harvard-Smithsonian Centre for Astrophysics) e David J. Wilner (Harvard-Smithsonian Centre for Astrophysics). “Abbiamo ora indizi ancora più chiari che questa stessa chimica sia presente in altri luoghi nell’Universo – osserva la scienziata – in regioni che potrebbero formare sistemi planetari simili al nostro”.
Ciò è particolarmente interessante, secondo la Öberg, perchè le molecole trovate in MWC 480 si trovano in concentrazioni simili nelle comete del Sistema Solare. La stella MWC 480, di massa pari a circa il doppio di quella solare, si trova a 455 anni luce dalla Terra, nella regione di formazione stellare della costellazione del Toro. Il disco che la circonda è nei primissimi stadi di sviluppo, recentemente formato dalla coalescenza di una nebulosa fredda e oscura di polvere e gas. Studi effettuati con Alma e altri telescopi devono ancora rivelare segni evidenti della formazione di esopianeti al suo interno, mentre osservazioni a più alta risoluzione potrebbero svelare strutture simili a HL Tauri, di età simile. Gli astronomi sanno da tempo che le nubi interstellari fredde e oscure sono fabbriche efficienti di molecole organiche complesse, tra cui un gruppo di molecole note come cianuri. I quali, specialmente il cianuro di metile, sono importanti perchè contengono legami carbonio-azoto, essenziali per la formazione degli aminoacidi, i fondamenti delle proteine che sono i mattoni della vita. Finora non era chiaro se queste stesse molecole organiche complesse si formassero comunemente e sopravvivessero nell’ambiente energetico di un nuovo sistema esoplanetario in formazione, dove gli urti e la radiazione possono rompere facilmente i legami chimici. Grazie alla sensibilità notevole di Alma, gli astronomi possono osservare direttamente queste molecole che non solo sopravvivono, ma prosperano! Le molecole viste da Alma sono molto più abbondanti di quanto si trovi nelle nubi interstellari, il che dimostra come i dischi protoplanetari siano molto efficienti nel formare molecole organiche complesse in tempi relativamente brevi. Il super radiotelescopio Alma è in grado di rivelare la debole radiazione nella banda millimetrica che viene emessa naturalmente dalle molecole nello spazio. Per queste osservazioni recenti, gli astronomi hanno usato una parte delle 66 antenne di Alma, quando il telescopio operava in una configurazione a bassa risoluzione. Ulteriori studi su questo e altri dischi protoplanetari, con la piena funzionalità di Alma, riveleranno nuovi dettagli sull’evoluzione chimica e strutturale di stelle e pianeti. La formazione rapida è fondamentale per superare le forze che altrimenti romperebbero le molecole individuate in una zona relativamente tranquilla del disco, a circa 4,5 e 15 miliardi di chilometri dalla stella centrale. Anche se molto lontana, secondo le misure del nostro Sistema Solare, nella scala più grande della stella MWC 480 questa zona si trova esattamente nella fascia di formazione delle esocomete. Mentre il sistema continua a evolversi, gli astronomi ipotizzano che probabilmente le molecole organiche chiuse al sicuro all’interno delle esocomete e di altri corpi ghiacciati verranno trasportate fino ad ambienti in grado di sostenere la vita. “Dallo studio degli esopianeti sappiamo che il Sistema Solare non è unico nè per numero di pianeti nè per l’abbondanza di acqua – rivela la Öberg – ora sappiamo che non siamo unici nemmeno per la chimica organica. Ancora una volta, abbiamo imparato di non essere speciali.
Dal punto di vista della vita nell’Universo, questa è una grande notizia”. L’oceano primitivo su Marte, con più acqua del Mar Glaciale Artico sulla Terra, copriva una frazione della superficie del Pianeta Rosso maggiore di quella del nostro Oceano Atlantico, secondo i nuovi risultati pubblicati da un’equipe internazionale di scienziati. Frutto di sei anni di osservazioni al Very Large Telescope dell’Eso, all’Osservatorio W.M. Keck e al telescopio infrarosso IRTF della Nasa, per controllare l’atmosfera di Marte e costruire una mappa delle proprietà dell’acqua nelle diverse zone dell’atmosfera marziana. Le osservazioni e le mappe risultanti sono le prime nel loro genere. I dati sono pubblicati dalla rivista Science nell’articolo intitolato “Strong water isotopic anomalies in the Martian atmosphere: probing current and ancient reservoirs”, di G.L. Villanueva e altri. L’equipe è composta da: G.L. Villanueva (NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, USA; Catholic University of America, Washington, D.C., USA), M.J. Mumma (NASA Goddard Space Flight Center), R.E. Novak (Iona College, New York, USA), H.U. Käufl (ESO, Garching, Germania), P. Hartogh (Max Planck Institute for Solar System Research, Göttingen, Germania), T. Encrenaz (Observatoire de Paris-Meudon, Paris, Francia), A. Tokunaga (University of Hawaii-Manoa, Hawaii, USA), A. Khayat (University of Hawaii-Manoa) e M. D. Smith (NASA Goddard Space Flight Center). Circa quattro miliardi di anni fa, il giovane Pianeta Rosso avrebbe avuto acqua a sufficienza per coprire l’intera superficie con uno strato liquido di circa 140 metri di profondità, ma è più probabile che il liquido fosse raccolto a formare un oceano che occupava metà dell’emisfero settentrionale di Marte e, in qualche zona, poteva raggiungere profondità superiori a 1600 metri. “Il nostro studio fornisce una stima solida di quanta acqua ci fosse un tempo su Marte – osserva Geronimo Villanueva del Goddard Space Flight Center della Nasa a Greenbelt (Maryland, Usa) – attraverso la determinazione di quanta acqua è stata persa nello spazio. Con questo lavoro possiamo capire meglio la storia dell’acqua su Marte”. La nuova stima è basata su osservazioni dettagliate di due forme leggermente diverse di acqua nell’atmosfera di Marte. Una è la forma che ci è familiare, composta da due atomi di idrogeno e uno di ossigeno, H2O. L’altra è HDO, o acqua semi-pesante, una variazione naturale di acqua in cui un atomo di idrogeno è sostituito da una sua forma più pesante, chiamata deuterio. Poichè la forma contenente deuterio è più pesante dell’acqua normale, viene persa più difficilmente nello spazio a causa dell’evaporazione e perciò maggiore è la perdita d’acqua dal pianeta e maggiore è il rapporto tra HDO e H2O nell’acqua che rimane. Negli oceani terrestri ci sono circa 3200 molecole di H2O per ogni molecola di HDO. I ricercatori hanno distinto l’impronta chimica dei due tipi di acqua marziana, “battendo” l’imponente schieramento di sonde automatiche terrestri disseminate sulla superficie e nell’atmosfera di Marte. Che possono fornire dettagli precisi da misure locali ma non sono adatte per il monitoraggio delle proprietà sull’intera atmosfera marziana: risultati che si ottengono più facilmente con spettrografi infrarossi montati su grandi telescopi da Terra. Così, confrontando il rapporto tra HDO e H2O, gli scienziati possono misurare di quanto è aumentata la frazione di HDO e perciò determinare quanta acqua è sfuggita nello spazio a causa del vento solare e del campo magnetico marziano sempre più debole. Ciò consente di stimare la quantità di acqua su Marte nei primordi. Nello studio l’equipe ha costruito una mappa della distribuzione di H2O e HDO ripetutamente nel corso di sei anni terrestri, corrispondenti a circa tre anni marziani, producendo istantanee globali di entrambi i tipi di acqua e del loro rapporto. Le mappe rivelano mutamenti stagionali e microclimi, anche se il Marte odierno è essenzialmente un deserto ghiacciato irradiato.
“Sono sopraffatto dalla capacità dei telescopi astronomici di studiare altri pianeti in remote – rivela Ulli Kaeufl dell’Eso, responsabile della costruzione di uno degli strumenti usati in questo studio e co-autore del nuovo articolo – abbiamo trovato un antico oceano a più di 100 milioni di chilometri!”. Il team scientifico era particolarmente interessato alle regioni vicine ai poli marziani, visto che le calotte polari ghiacciate sono la più grande riserva di acqua nota sul Pianeta Rosso. L’acqua ivi immagazzinata dovrebbe documentare l’evoluzione dell’acqua su Marte dall’Era Noachiana, umida, terminata circa 3,7 miliardi di anni fa, fino a oggi. I nuovi risultati mostrano che l’acqua atmosferica nelle regioni vicine al polo, è stata arricchita di un fattore sette rispetto all’acqua degli oceani terrestri, mentre quella nelle calotte ghiacciate permanenti è arricchita di un fattore otto. Marte deve aver perso un volume di acqua 6,5 volte maggiore delle attuali calotte polari per fornire questo livello di arricchimento. Il volume degli oceani primordiali di Marte sarebbe stato perciò di almeno 20 milioni di chilometri cubi. Ora, basandosi sulla superficie odierna di Marte, la localizzazione probabile di quest’acqua dovrebbe essere nelle pianure settentrionali, a lungo considerate un “buon candidato” a causa dei terreni a bassa quota. Un antico oceano avrebbe coperto il 19 percento dell’antica superficie del Pianeta Rosso. Per confronto, l’Oceano Atlantico copre il 17 percento della Terra. “Se Marte ha perso così tanta acqua – spiega Michael Mumma – il pianeta è stato probabilmente umido per un periodo più lungo di quanto si pensasse in precedenza, e ciò suggerisce che Marte avrebbe potuto essere abitabile per un periodo maggiore”. La mente è libera di fantasticare quanto crede. È possibile che Marte abbia avuto anche più acqua, parte della quale potrebbe essersi depositata sotto la superficie. Poichè le nuove mappe rivelano la presenza di microclimi e cambiamenti, nel tempo, del contenuto atmosferico di acqua, questi dati potrebbero essere utili anche per continuare a cercare l’acqua sotterranea. Il lavoro è sostenuto da quattro Programmi sviluppati al quartier generale della Nasa a Washington D.C.: Mars Fundamental Research, Planetary Astronomy, Atmosfere Planetarie e NASA Astrobiology. Sebbene siano millenni che l’Uomo Esploratore attribuisce nomi agli oggetti celesti, è la I.A.U. ad avere in questo momento il compito di assegnarne di scientificamente validi a tutti i nuovi corpi scoperti dalla Terra. Visto l’altissimo numero di esopianeti rilevati negli ultimi vent’anni, si è pensato di promuovere una campagna originale che dà la possibilità a tutti, non solo agli astronomi, di attribuire un nome agli esomondi alieni sempre più popolari, evidentemente con tutto il rispetto dovuto alle probabili civiltà, imperi, domini, reami, federazioni e confederazioni galattiche finora ignote ai terrestri. Sì perchè tra gli aspetti più intriganti e innovativi c’è anche il fatto che i nomi non saranno attribuibili solo agli esopianeti ma anche alle stelle attorno alle quali essi orbitano, che sono note da secoli e secoli e alle quali per la prima volta è possibile provare a dare tutti un nome! Il contest “NameExoWorlds”, organizzato da I.A.U. e Zooniverse, è entrato nella sua penultima fase e il termine per sottomettere la proposta è, per chi risponderà al bando congiunto INAF-SAIt, la Mezzanotte del 20 Maggio 2015. Per chi invece ha la possibilità di effettuare una propria iscrizione nella “directory” I.A.U., il termine è la Mezzanotte del 15 Giugno 2015. La proposta può essere infatti avanzata solo ed esclusivamente dalle organizzazioni no profit, associazioni amatoriali e divisioni per la divulgazione di enti quali l’INAF e SAIt, che si siano iscritte alla Directory I.A.U. entro e non oltre la Mezzanotte del 1° Giugno 2015. Una volta conclusa questa fase di presentazione e classificazione dei nomi, si aprirà la votazione pubblica alla quale sarà chiamato il pubblico di tutto il Mondo per scegliere i nomi preferiti di esomondi e stelle della Galassia! La lista dei 20 Sistemi Solari alieni più popolari a cui è possibile attribuire il nome, la maggior parte dei quali risulta visibile ad occhio nudo, è ora ufficiale e disponibile al seguente indirizzo (www.nameexoworlds.org/the_exoworlds). È un censimento interstellare a tutti gli effetti.
Chissà, i futuri esploratori intergalattici sono proprio tra di voi. Per ExoWorlds, l’I.A.U. intende il Sistema complessivo, formato dalla stella e dagli esopianeti extrasolari alieni. Tra i 20 ExoWorld scelti, 15 sono formati da un solo esopianeta intorno alla stella mentre i restanti hanno più di un pianeta intorno alla stella. Il numero di nomi che si deve sottoporre nella proposta dipende quindi dal tipo di Sistema che si sceglie. In tutti i Sistemi, tranne 5 casi eccezionali, si deve assegnare il nome sia alla stella sia al/ai esopianeta/i. Le 5 eccezioni si riferiscono ai Sistemi formati da stelle già famose, con nomi ormai storici, che non è più possibile cambiare. In totale gli oggetti che per l’Estate 2015 avranno un nome proprio sono 47, con 15 stelle e 32 esopianeti. Per chi vuole cimentarsi in una proposta e non fa parte di associazioni che possono registrarsi in modo indipendente sul sito I.A.U., entro il 1° Giugno, l’INAF e SAIt hanno istituito un bando (www.media.inaf.it/wp-content/uploads/2015/04/Bando_NameExoworlds.pdf) al quale inviare la proposta entro e non oltre la Mezzanotte del 20 Maggio 2015. Oltre al bando INAF-SAIt, per facilitare e stimolare le persone in questa divertente sfida, si è pensato di pubblicare ogni giorno per 7 giorni, una piccola news descrittiva per ciascuno dei 20 Sistemi esoplanetari, e per alcuni di essi ci sono anche dei messaggi da parte degli scopritori stessi! È possibile trovare informazioni sulla Rubrica “ExoWorld – Menù del giorno” pubblicata nella pagine FaceBook di “Uno, Nessuno, Centomila Sistemi Solari”, e sui due Blog “Tutti Dentro” e “GruppoLocale”. È stata inoltre istituita una Commissione composta da 7 esperti nel campo della divulgazione astronomica e della ricerca degli esopianeti, che valuterà tutte le proposte ricevute per sottoporre le due migliori. I risultati finali di questa campagna verranno annunciati durante una cerimonia pubblica speciale prevista durante la XXIX General Assembly di I.A.U. a Honolulu (Hawaii, Usa) che si terrà dal 3 al 14 Agosto 2015. Il suo nome è Webb, James Webb. Sarà il Telescopio Spaziale universalmente considerato l’erede dell’Hubble Space Telescope. Anche questo nuovo gioiello è intitolato a uno dei padri statunitensi dell’esplorazione dello Spazio. Edwin Hubble è l’astronomo noto per aver formulato nel 1929, insieme a Milton Humason, la legge empirica sulla velocità di recessione delle galassie, che conferma l’ipotesi dell’espansione dell’Universo. James Webb è stato il secondo amministratore della Nasa, chiamato nel 1961 alla guida dell’Agenzia Spaziale dal Presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy, per rendere realtà il suo storico discorso del “We choose to go to the moon…”.
Un sogno coronato nel 1968-69 con le prime due missioni lunari Apollo 8 e Apollo 11. Così ora, il nome di Webb è legato indissolubilmente anche al più avanzato strumento per indagare l’Universo che ci apprestiamo a lanciare stavolta al di fuori dell’atmosfera terrestre. A 1,5 milioni di Km dalla Terra. I piani di Nasa, Csa (Agenzia spaziale Canadese) ed Esa (Agenzia spaziale europea) prevedono la messa in orbita del James Webb Space Telescope (JWST) entro il 2018, secondo lo stato attuale di sviluppo dell’ambizioso programma. Se così sarà, la fine di questo decennio potrebbe vedere i due telescopi terrestri lavorare insieme per scoprire i veri Extraterrestri, nell’attesa, si spera il più tardi possibile, del pensionamento definitivo di Hubble, con il suo recupero (non disintegrazione!) grazie al primo space shuttle europeo. Il JWST è considerato ormai universalmente l’erede di Hubble, ma non sarà banalmente la sua copia. “Il JWST non sarà semplicemente una copia rivista e modernizzata di HST – rivela Roberto Maiolino, professore al Cavendish Laboratory, il Dipartimento di Fisica dell’Università di Cambridge, membro del team dello strumento NIRSpec a bordo del JWST – sia in termini di tecnologie utilizzate sia in termini di prestazioni scientifiche, è radicalmente diverso da HST. Dal punto di vista delle implicazioni per l’Astrofisica le differenze più importanti sono due: intanto, lo specchio primario di JWST, che ha un diametro di 6,5 metri, è quasi tre volte più grande di quello di HST. Questo significa che la superfice di raccolta dei fotoni nel JWST sarà circa sette volte maggiore di quella di HST. Un telescopio così grande non è stato mai lanciato nello spazio. Essenzialmente JWST è un telescopio di dimensioni simili ai grandi telescopi da terra (come ad esempio MMT, Magellan, e di poco inferiore al Very Large Telescope dell’Eso) ma operativo nell’ambiente spaziale, lontano dalla Terra, con pochissimo inquinamento luminoso e senza i problemi di deteriorazione dell’immagine dovuti all’atmosfera terrestre. Poi, JWST è ottimizzato per le osservazioni infrarosse, in particolare nella banda a lunghezze d’onda fra 1 e 27 micron. In tale banda sono osservabili una vasta gamma di fenomeni unici, che non hanno controparte in altre bande, che ci consentiranno di caratterizzare con una precisione senza precedenti numerose classi di sorgenti astronomiche, nonché la scoperta e l’identificazione di nuove categorie di oggetti celesti”. Sono moltissimi i campi d’indagine che vedranno impegnato JWST. “Il Telescopio JWST consentirà un salto gigantesco in quasi tutti i settori dell’Astronomia. Per dare un’idea di questo miglioramento, basti pensare che in alcune bande spettrali la sensibilità di JWST sarà circa cento/mille volte superiore a qualsiasi telescopio disponibile al momento. Un tale salto è equivalente, in termini di sensibilità, a passare repentinamente dal telescopio di Galilei al Very Large Telescope! I campi d’indagine di JWST saranno quindi vastissimi. Uno dei settori per i quali c’è maggiore eccitazione e aspettativa, è lo studio delle atmosfere dei pianeti in altri sistemi solari. Infatti, JWST consentirà di identificare diverse specie molecolari nelle atmosfere di pianeti extrasolari, permetterà di caratterizzare le proprietà fisiche di tali atmosfere e consentirà anche di valutare se alcuni di questi pianeti presentino le condizioni adatte per lo sviluppo della vita. La sensibilità di JWST nelle bande infrarosse sarà fondamentale per penetrare le dense nubi di polvere in cui si formano nuove stelle nella nostra Galassia, come pure in altre galassie, e ci permetterà quindi di studiare in dettaglio il processo che porta alla formazione delle stelle, nonché alla formazione dei pianeti nei dischi circumstellari. Un altro settore in cui JWST avrà un enorme impatto è lo studio delle galassie distanti. Le prime galassie che si sono formate nell’Universo primordiale sono estremamente deboli (sia perché molto distanti, sia perché intrinsecamente poco luminose e con un modesto contenuto di stelle) e la loro radiazione è osservabile solo nelle bande infrarosse, dove le osservazioni da terra sono estremamente difficili. JWST consentirà per la prima volta di identificare, e caratterizzare in dettaglio, tali galassie primordiali. Questo è uno dei casi scientifici principali di JWST, tanto che è stato soprannominato The First Light Telescope.
Questi sono solo alcuni dei principali campi d’indagine di JWST. Ma le capacità osservative senza precedenti di JWST avranno un impatto enorme in molti altri settori. C’è da dire che, con un salto talmente enorme di sensibilità, si apriranno realmente orizzonti totalmente inesplorati. Ci aspettano quindi scoperte che attualmente non possiamo neanche concepire”. Il dominio dello spettro elettromagnetico in cui osserverà JWST è compreso tra la parte rossa della luce visibile e il medio infrarosso. “Per poter operare con la massima efficienza e sensibilità nelle bande infrarosse l’intera struttura del Telescopio dovrà essere riparata dalla radiazione del Sole, ma anche dalla radiazione infrarossa della Terra e della Luna. Quest’obiettivo viene raggiunto tramite giganteschi scudi termici, con dimensioni che raggiungono i 20 metri, i quali si apriranno una volta che il Telescopio sarà in orbita. All’ombra di questi scudi il Telescopio si raffredderà fino ad una temperatura inferiore a meno 220 gradi Celsius; in questo modo l’emissione termica del Telescopio nelle bande infrarosse (che altrimenti abbaglierebbe tutti gli strumenti) sarà trascurabile rispetto ad altre sorgenti di inquinamento luminoso che non sono evitabili, quali la Luce Zodiacale del nostro Sistema Solare. Gli scudi termici, da soli, non potrebbero però riparare il Telescopio simultaneamente dal Sole, dalla Terra e dalla Luna, se JWST orbitasse attorno alla Terra come nel caso di HST. Per questo motivo JWST orbiterà attorno al punto Lagrangiano L2, situato a circa 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, nella direzione opposta al Sole. L2 è un punto di equilibrio gravitazionale semi-stabile risultante dall’azione combinata delle forze gravitazionali esercitate dalla Terra e dal Sole: orbitando attorno a tale punto, gli scudi termici potranno essere orientati in maniera tale da riparare il Telescopio simultaneamente dal Sole, dalla Terra e dalla Luna. Lo strumento che opera nel medio infrarosso (MIRI) avrà poi bisogno di essere raffreddato ulteriormente, scendendo fino ad una temperatura di meno 266 gradi Celsius.
Un raffreddatore criogenico sviluppato appositamente per JWST consentirà allo strumento di raggiungere tale temperatura. Inoltre, tutti gli specchi di JWST sono ricoperti d’oro (anziché d’allumino come negli specchi classici utilizzati principalmente dai telescopi ottici) perché l’oro riflette la radiazione infrarossa più efficientemente”. Realizzare un Telescopio così sofisticato impone progressi tecnologici estremi. “JWST è un concentrato di altissima tecnologia, praticamente in tutti i suoi componenti. Diverse tecnologie d’avanguardia sono state sviluppate appositamente per JWST. Un esempio di una di queste è chiaramente visibile semplicemente guardando il modello di JWST: il suo specchio primario non è uno specchio monolitico, bensì composto da 18 segmenti, ciascuno del diametro di 1,3 metri. Parte di questi specchi verranno ripiegati nella parte posteriore del telescopio, in modo da poter accomodare il telescopio nel vettore di lancio, e verranno riportati in posizione solo una volta che il Telescopio sarà in orbita. Per poter mantenere i segmenti in una configurazione tale che il loro insieme corrisponda ad un’unica superficie riflettente e che non degradi l’immagine delle sorgenti astronomiche, la posizione e la curvatura di ciascun segmento sarà periodicamente aggiustata da un sistema di controllo dedicato. È la prima volta che un sistema di ottiche attive viene utilizzato in orbita per un Telescopio di tali dimensioni. Un altro esempio di tecnologia di punta è il Micro Shutter Array, un vero gioiello tecnologico che viene utilizzato nello spettrometro operante nel vicino infrarosso (NIRSpec). Questa è una matrice di circa 62.000 micro-sportelli (ciascuno di dimensioni di 200 micron) i quali possono essere aperti a comando nella configurazione desiderata dall’astronomo. Utilizzando queste matrici situate sul piano focale del Telescopio è possibile selezionare le sorgenti astronomiche per le quali si desidera ottenere uno spettro (ovvero identificare le diverse componenti della radiazione emessa). Anche i rivelatori infrarossi hanno richiesto uno sviluppo specifico affinché avessero i requisiti necessari per poter sfruttare pienamente le potenzialità di JWST. Il cryocooler per MIRI è un altro esempio di un sistema che ha richiesto lo sviluppo di tecnologie d’avanguardia affinché se ne potesse garantire il funzionamento in orbita con le specifiche richieste”. Roberto Maiolino è nel team scientifico della missione. “Io faccio parte del team scientifico dello spettrometro che opera nel vicino infrarosso, NIRSpec. Questo è il più complesso e il più grosso degli strumenti a bordo di JWST. Si tratta di un capolavoro tecnologico: utilizzando quattro Micro Shutter Arrays consentirà di ottenere spettri di qualche centinaio di oggetti astronomici simultaneamente. Sarà il primo spettrometro multi-oggetto ad operare dallo spazio. La spettroscopia non è stata uno dei punti di forza di HST (sebbene il modo “slitless” di WFC3 abbia consentito notevoli progressi). Generalmente, per l’identificazione e la caratterizzazione spettroscopica delle sorgenti scoperte da HST si sono dovuti utilizzare i grandi telescopi da terra. Nel caso di JWST la spettroscopia gioca invece un ruolo centrale. Le sorgenti che verranno scoperte da JWST saranno così deboli, e con emissione a lunghezze d’onda inaccessibili da terra, che la loro identificazione e caratterizzazione spettroscopica sarà fattibile solo con JWST stesso. Lo strumento NIRSpec avrà a disposizione per le osservazioni anche di una modalità di spettroscopia integrale grazie alla quale sarà possibile ottenere una mappatura tridimensionale di singoli oggetti celesti. La flessibilità e gamma di modi osservativi offerti da NIRSpec apre il suo utilizzo ai più svariati obiettivi scientifici. Alcuni dei principali sono certamente la caratterizzazione delle atmosfere dei pianeti extrasolari e la ricerca e la caratterizzazione delle prime galassie formatesi nell’Universo primordiale”. La partecipazione europea alla missione JWST è significativa. “Il contributo europeo a JWST è molto maggiore di quanto non sia stato per HST. L’Agenzia Spaziale Europea ha fornito lo spettrometro NIRSpec, fornirà il razzo di lancio Ariane 5 (uno dei pochissimi vettori grandi a sufficienza da poter ospitare JWST, sebbene ripiegato, al suo interno) e contribuirà significativamente alle operazioni di JWST. Inoltre un consorzio formato da numerosi istituti di ricerca europei ha realizzato lo strumento operativo nel medio infrarosso, MIRI, cui hanno contribuito anche gli Stati Uniti d’America fornendo i rivelatori e il cryocooler. L’Italia, e in particolare l’Agenzia Spaziale Italiana, purtroppo è rimasta un po’ fuori, essendo uno dei pochi Paesi che non ha partecipato al consorzio MIRI. Tuttavia, gli istituti italiani ospitano diversi fra i migliori ricercatori a livello mondiale in molti settori dell’Astrofisica. Non ho alcun dubbio che i ricercatori italiani saranno fra i più competitivi e i più agguerriti nell’ottenere ampie fette di tempo osservativo con JWST”. Il Telescopio Spaziale Hubble ha ormai una notorietà eccezionale, non solo tra gli addetti ai lavori. E questo anche grazie alle sue immagini mozzafiato che da 25 anni invia dallo spazio. “Sinceramente penso che JWST eclisserà completamente HST. L’accesso alle bande infrarosse mostrerà con una prospettiva completamente diversa e nuova la varietà di sorgenti astronomiche. Inoltre, molti dei temi chiave che verranno affrontati magistralmente da JWST avranno sicuramente un impatto enorme anche sul grande pubblico”. Ben 25 anni fa, il 24 Aprile 1990, l’Hubble Space Telescope (HST) parte da Cape Canaveral a bordo dello Space Shuttle Discovery, la navetta con le ali oggi al museo. Venticinque anni di emozioni intense, di risultati scientifici che hanno rivoluzionato la nostra conoscenza dell’Universo vicino e lontano, ma anche la sua percezione, più di quanto sia riuscito a fare nessun altro, satellite, telescopio o teorico della scienza e della filosofia. Hubble ci ha permesso di vedere tutto quello che volevamo e molto di più di quel che potevamo immaginare, dal sito lunare dell’atterraggio degli astronauti dell’Apollo 17, alle tempeste su Giove i cui satelliti sono pieni d’acqua, alla scoperta di nuovi pianeti extrasolari, alle stelle appena nate e appena morte, alle galassie vicine o lontanissime, ai confini dell’Universo e del tempo. Nei quattro giorni del convegno organizzato a Baltimora dallo Space Telescope Science Institute per celebrare il venticinquesimo anniversario del lancio di HST e per illustrare quanto questo meraviglioso Telescopio può ancora regalare all’Umanità negli anni a venire, gli scienziati hanno illustrato le sue principali scoperte scientifiche, da quelle fatte finora a quelle in programma per il futuro: dalle immagini dell’impatto di una cometa e di un meteorite su Giove, alle prime evidenze di un pianeta extrasolare che transita davanti alla sua stella, dalle caratteristiche chimico-fisiche delle atmosfere di pianeti e satelliti del Sistema Solare e di altri sistemi planetari al cuore dei Buchi Neri e della Supermateria. Tutti hanno capito quanto HST possa ancora insegnare su come si formano e evolvono le stelle e le galassie. Due degli astronomi che hanno ricevuto il Nobel per la Fisica grazie alle osservazioni con HST, integrate anche da spettroscopia da terra, di Supernovae di tipo Ia che hanno fornito nel 1998 un’evidenza ormai incontestabile dell’accelerazione dell’Universo. Senza contare le nuove, sempre clamorose, immagini dei campi iper-profondi dove miriadi di galassie di tutte le forme, dimensioni, età e distanze riempiono uno spazio inferiore al pollice umano che a un altro telescopio sembra vuoto! Gli Italiani (sia quelli che lavorano in Italia nell’INAF o nelle Università, sia quelli che lavorano in istituzioni all’estero) hanno dato un contributo di primo piano alle scoperte di Hubble, soprattutto nello studio delle regioni di formazione stellare, delle popolazioni stellari risolte, dell’evoluzione delle galassie vicine e lontane, nello sfruttamento delle lenti gravitazionali previste da Albert Einstein.
La Scienza deve moltissimo a Hubble, forse quanto al cattolico Galileo Galilei che eppur credeva. Ma il successo mediatico del primo vero Telescopio Spaziale va perfino oltre i suoi eccezionali meriti scientifici perchè legato all’impatto psicologico che ha avuto su moltissime persone. “Fatti non fummo a viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza”, insegna il sommo Poeta. HST è diventato presto il modo per conoscere meglio l’Universo senza quasi alzarci dalla poltrona di casa, non solo per gli astronomi, ma per persone che nella vita si occupano di tutt’altro. Per tantissime persone Hubble è l’epopea dei pionieri senza i rischi del Far West, la novella caravella di Colombo senza rischio di naufragio, la nave di Ulisse oltre le Colonne d’Ercole senza destini avversi. Da un computer si è subito connessi con Hubble e la Verità. Tutti insieme appassionatamente abbiamo seguito, ora con ansia, ora con entusiasmo, le sue vicende e le sue vicissitudini, dalle tragedie degli Space Shuttle (prima il Challenger nel 1986 e poi il Columbia nel 2003) che ne hanno ritardato il lancio, fino all’ultima missione di manutenzione, al trionfo della famosa Servicing Mission 4, nel Maggio 2009, incollati alla diretta streaming insieme all’astronauta John Grunsfeld per tirare quel maledetto portello che non voleva venir via, per inserire come previsto tutti i nuovi strumenti. Tutti insieme appassionatamente intorno alla Terra. HST è “nostro” per sempre, chiunque siamo e ovunque siamo, dunque bisogna riportarlo a casa sano e salvo! Quando la Nasa mise a terra tutti gli Space Shuttle dopo il disastro del Columbia, il 1° Febbraio 2003, cancellando così la Servicing Mission 4, la reazione in tutto il mondo fu di disperazione: appelli e petizioni partirono da ogni Paese, dalle Società Astronomiche ma anche da singoli cittadini. Un Americano scrisse che, con il lavoro frustrante che faceva, se non avesse più avuto la sua nuova immagine di HST da vedere ogni giorno a colazione, non avrebbe saputo come andare avanti. Gli astronauti scrissero semplicemente che la loro professione implica inevitabilmente rischi letali, ma che se dovevano morire per qualcosa, preferivano morire per l’Hubble Space Telescope che per altro. Venticinque anni di sfide continue e successi clamorosi. HST, come noi umani, non è nato perfetto, ma è la miglior metafora del sogno euro-americano che si potesse produrre: anche se nasci brutta anatroccola, l’ingegno umano e la dedizione di chi ti ha a cuore possono farti diventare il più bel cigno dell’Universo. L’imperfezione iniziale, combinata con il lavoro geniale e tutto umano di chi ha capito come correggere l’imperfezione ottica, i cedimenti strumentali legati all’invecchiamento e le intuizioni su come aggirarli, ce lo hanno reso anno dopo anno più caro e prezioso. Ora la Nasa pensa di poter tenere Hubble operativo almeno fino al 2020, in modo da avere un paio di anni o più con sia lui che il James Webb Space Telescope attivi contemporaneamente, una sinergia importantissima perché HST e JWST guardano a lunghezze d’onda diverse e con strumenti diversi. Noi Europei, finalmente in Pace e Uniti insieme alla Santa Madre Russia, contiamo che l’Esa continui a partecipare fino in fondo a questa impresa meravigliosa. In 25 anni il Telescopio Spaziale Hubble non ha smesso un giorno di stupirci, di regalarci meravigliose immagini dell’Universo e di emozionarci con sensazionali scoperte. Ammassi globulari, regioni di formazione stellare, galassie vicine e lontane, nebulose planetarie, formazione stellare cosmica, fino alle galassie primitive quasi alle origini dell’Universo. Sono questi alcuni dei protagonisti delle centinaia di migliaia di immagini pubblicate in questi anni dal team di HST. Il 24 Aprile 1990 lo Shuttle Discovery con la missione STS-31 parte dal Complesso di lancio 39 del John F. Kennedy Space Center in Florida, portando Hubble nello spazio e spingendosi fino a quasi 600 chilometri sulla superficie terrestre. Una quota relativamente alta per uno Shuttle dell’epoca ma anche per la Stazione Spaziale Internazionale che oggi orbita a 400 chilometri di altezza, ma anche relativamente bassa tanto da poter consentire frequenti missioni di servizio per riparare guasti e per installare nuovi strumenti: ne sono state effettuate ben cinque.
Accadrà lo stesso con il JWST senza un vero Space Shuttle degno di questo nome? È proprio questo particolare punto di vista che ha reso HST speciale negli anni. A differenza dei telescopi costruiti a terra, i telescopi orbitanti (Hubble non è solo lassù!) riescono a sfuggire alle distorsioni della luce causate dall’atmosfera terrestre dall’inquinamento luminoso elettromagnetico. E anche per questo le immagini che vengono inviate a terra sono nitide ed estremamente suggestive. L’idea di costruire un Telescopio orbitante risale alla fine degli Anni ’40, quando l’astronomo Lyman Spitzer, a cui poi venne dedicato un telescopio cacciatore di pianeti, scrisse una relazione sui vantaggi di un osservatorio extraterrestre. Nel 1977, il congresso americano approvò il finanziamento per il Large Space Telescope che, molti anni dopo, divenne l’Hubble Space Telescope, chiamato così negli Anni ’80 in onore di quello che per molti è il più grande astronomo del XX Secolo, Edwin Powell Hubble, il quale dimostrò l’esistenza di altre galassie oltre la nostra e enunciò la teoria sull’Universo in continua espansione con la sua Legge nel 1929. In realtà HST, il cui costo al lancio fu stimato attorno ai 1,5 miliardi di dollari, sarebbe dovuto partire per l’orbita bassa della Terra già nel 1986, ma la missione venne rimandata dopo il tragico disastro dello Space Shuttle Challenger, esploso 73 secondi dopo il lancio. Nessuno degli astronauti sopravvisse alla tragedia. I voli nello spazio con equipaggio non ripresero prima di due anni. La missione Hubble ricevette l’Ok definitivo nel 1990, ma già a pochi giorni dal lancio il team di HST apprese la prima notizia negativa. Un macigno sulle teste dei ricercatori che per più di dieci anni avevano lavorato al progetto. Lo specchio primario di Hubble (2,4 metri di diametro) che può spingere il suo sguardo lontanissimo fino ai primissimi anni di vita dell’Universo, era difettoso. La società costruttrice calibrò male lo specchio che riportò un’imperfezione di 1/50 dello spessore di un foglio di carta. Poco per gli umani, ma abbastanza grave da deviare la luce e da distorcere le immagini che venivano inviate a terra. Il che non era esattamente quello che gli esperti si aspettavano: le immagini di Hubble avrebbero dovuto essere subito nitide più che mai. Nel 1993, dopo 11 mesi di addestramento, un gruppo di coraggiosi astronauti partì a bordo dello Space Shuttle Endeavour per la prima missione di servizio (STS-61) verso Hubble, portando in orbita il Corrective Optics Space Telescope Axial Replacement (COSTAR). La riparazione dello specchio primario in orbita (COSTAR introdusse un errore uguale ed opposto in modo da annullare il difetto) costò alla Nasa la bellezza di 600 milioni di dollari. Grazie alla nuova ottica (lenti a contatto messe sullo specchio primario) e alla Wide Field/Planetary Camera (WF/PC2), a quattro anni dal lancio, nel 1994 HST mostrò diverse immagini nitide e dettagliate, come quella in cui si vede la cometa Shoemaker–Levy 9 schiantarsi contro Giove nel mese di Luglio. Dopo soli 5 anni in orbita, nel 1995, Hubble portò a casa una delle immagini che forse lo hanno consacrato definitivamente nell’Olimpo scientifico, facendolo conoscere tra il grande pubblico. Parliamo dei famosi Pilastri della Creazione, ovvero la Nebulosa dell’Aquila (M16), a 7000 anni luce dalla Terra, nella costellazione del Serpente appartenente alla Via Lattea. Nell’Aprile 2015 gli scienziati hanno festeggiato proprio i 20 anni di questa storica foto, quando il team di Hubble ha regalato al mondo una nuova versione dello scatto. Come la prima volta, si vedono nitide nel cielo tre torri imponenti, lunghe anni luce, di gas e ciuffi multicolore di polvere cosmica, ma la nuova foto di HST è ovviamente più nitida e profonda, grazie alla maggiore sensibilità dello strumento attuale WFC3 rispetto alla WFPC2 montata appunto 20 anni fa. Dopo quella del 1993, vi sono state altre quattro missioni di servizio con cui gli astronauti hanno riparato e aggiunto di volta in volta nuovi strumenti ad Hubble, portando il suo peso iniziale di 11mila a oltre 12mila chilogrammi (800 Kg solo di specchio). Nel 1997, con la missione STS-82, l’equipaggio dello Space Shuttle Discovery porta in orbita gli strumenti STIS (Space Telescope Imaging Spectrograph) e NICMOS (Near Infrared Camera and Multi-Object Spectrograph). La terza missione del 1999 (STS-103) ripara i sei giroscopi del Telescopio, aggiungendo anche un computer di bordo. Nel 2002, l’equipaggio della missione STS-109 installa l’ACS (Advanced Camera for Surveys), il NICMOS Cooling System (NCS) e nuovi pannelli solari. L’ultima missione di servizio è la STS-125, compiuta a bordo dello Space Shuttle Atlantis. Originariamente prevista per il 2005, il lancio viene rimandato a causa del disastro dello Space Shuttle Columbia, esploso sui cieli del Texas, al rientro di una missione, causando la morte dei sette astronauti a bordo. Nel 2006 la Nasa autorizza una nuova missione che parte l’11 Maggio 2009.
Gli astronauti dell’Atlantis portano in orbita nuovi strumenti per HST, quelli che ancora oggi sono pienamente funzionanti: la celebre WFC3 (Wide Field Camera 3) e il COS (Cosmic Origins Spectrograph) che hanno reso Hubble 100 volte più potente rispetto a quando venne lanciato 25 anni fa. Gli astronauti installano anche il Soft Capture Mechanism e i NBLs (New Outer Blanket Layers). L’equipaggio del 2009, una volta nello spazio a 600 Km di quota, bersagliati quindi da micrometeoriti e radiazioni, celebra anche il quarto centenario delle scoperte celesti di Galileo Galileo, puntando verso le stelle una replica del famoso piccolo telescopio che permise a Galilei di scoprire le lune medicee, messa a disposizione dal Museo di Storia della Scienza di Firenze, dov’è conservato lo strumento originale.
Quindi il coinvolgimento della comunità scientifica italiana ed europea è stato importante fin dall’inizio dell’Era HST, soprattutto con la partecipazione alla costruzione della Faint Object Camera dell’Esa. Molti sono i ricercatori coinvolti che ricoprono ruoli chiave allo Space Telescope Science Institute di Baltimora (Usa) che gestisce le attività scientifiche di HST (http://hubble25th.org/). Nell’Estate del 2011 il team di Hubble festeggia la milionesima osservazione con un’analisi spettroscopica dell’esopianeta alieno HAT-P-7b riuscendo a confezionare la bellezza di 60 terabyte di dati nell’archivio digitale. Ad oggi si contano oltre 1,2 milioni di analisi. Nel 2011 è stato anche pubblicato il “paper” numero 10mila. Hubble è, infatti, uno dei Telescopi più produttivi di sempre. Ad oggi sono stati pubblicati quasi 13mila studi scientifici sulle riviste di tutto il Mondo. Tra le diverse ricerche pubblicate negli ultimi anni, ce n’è una che ha reso Hubble ancora più celebre e importante. Nel 2012 HST fotografa sette galassie primordiali appartenenti a una lontanissima popolazione che si formò ben 13 miliardi di anni fa. Si tratta di galassie fotografate quando avevano appena il 4 percento dell’età attuale. Qualche mese dopo, Hubble infrange il suo stesso record osservando un oggetto risalente a soli 470 milioni di anni dopo il Big Bang, quando l’Universo aveva il 3 percento della sua età attuale. Attenzione a non confondere l’età del Cosmo con le sue attuali dimensioni che sono davvero da capogiro! Gli scienziati affermano che Hubble, ancora in perfetta salute, continuerà a funzionare almeno fino al 2020, sovrapponendosi per qualche anno al suo atteso successore, il James Webb Space Telescope attualmente in fase di costruzione avanzata. Dopo il 2020, le componenti di Hubble cominceranno presto a smettere di lavorare, in maniera graduale, fino al completo spegnimento dell’intera macchina. Poi cosa succederà? Secondo il vecchio programma Hubble continuerà ad volare attorno alla Terra fino a quando non potrà più rimanere in orbita: dovrebbe precipitare inesorabilmente sull’oceano a spirale.
Se inizialmente la Nasa ipotizzava di poter riportare HST sulla Terra con uno Shuttle, in modo da poterlo esporre al pubblico, per l’America oggi ovviamente non è più possibile. L’era degli Shuttle si è chiusa per gli Usa nel 2011 con l’ultimo volo dell’Atlantis dopo 30 anni di missioni. Ma per l’Europa insieme alla Russia, non è un’impresa impossibile da realizzare. E i cittadini europei vogliono salvare l’Hubble Space Telescope. Magari grazie a uno space shuttle made in Europe di nuova generazione in grado di riportare a casa il Telescopio Spaziale più amato di sempre. Se un giorno dovremo dire addio ad Hubble, lo faremo staccando un biglietto al museo! Hubble non viaggia verso stelle, pianeti o galassie, ma resta ancorato alla sua orbita di 600 Km di quota. HST non riesce a osservare il Sole, perché troppo luminoso, né Mercurio, perché troppo vicino alla nostra stella madre. Ad oggi Hubble ha percorso oltre 4,8 miliardi di chilometri lungo l’orbita bassa terrestre. Hubble non ha dei propulsori e per cambiare gli angoli di puntamento utilizza i principi della Terza Legge di Newton facendo ruotare i giroscopi (che nel corso degli anni hanno subito diverse operazioni di manutenzione) in direzione opposta. Per ruotare di 90 gradi, HST impiega 15 minuti. Hubble ha una precisione di puntamento di 0,007 secondi d’arco, che è come essere in grado di puntare un raggio laser su una monetina a 320 chilometri di distanza. Libero dalle interferenze della nostra atmosfera, HST riesce a fotografare oggetti con una dimensione angolare di 0,05 secondi d’arco. L’archivio Hubble contiene più di 100 terabyte di dati e l’elaborazione delle nuove osservazioni genera circa 10 terabyte di nuovi dati ogni anno. Ogni giorno, invece, il Telescopio invia sulla Terra 120 gigabyte di dati, ossia 26 Dvd. Hubble misura 13,3 metri, la lunghezza di un grande autobus. Nonostante le mastodontiche dimensioni bastano 2800 Watt per farlo funzionare. Un bollitore per il thè ne richiede 2200. Hubble è un telescopio ottico e con il suo specchio cattura la luce a diverse lunghezze d’onda usando camere e strumenti all’avanguardia. Attualmente a bordo ci sono: la Wide Field Camera 3 (WFC3), che percepisce tre tipi di luce: ultravioletto vicino, visibile e vicino infrarosso; il Cosmic Origins Spectrograph (COS) che percepisce solo la luce ultravioletta; l’Advanced Camera for Surveys (ACS) in luce visibile; lo Space Telescope Imaging Spectrograph (STIS), uno spettrografo che lavora nell’ultravioletto, visibile e vicino infrarosso; la Near Infrared Camera and Multi-Object Spectrometer (NICMOS), che è il sensore di calore di Hubble, sensibile alla luce infrarossa quindi necessario per scrutare oggetti nascosti dalla polvere interstellare; i Fine Guidance Sensors (FGS), sensori che aiutano Hubble a puntare nella giusta direzione. Il Telescopio ci ha insegnato un sacco di cose interessanti sull’Universo. Anche a cucinare il pianeta Terra perfetto per l’Umanità in Pace: una tazza di magnesio, una di silicio, due di ferro e due di ossigeno; poi un mezzo cucchiaino di alluminio, un altro mezzo di nichel e di calcio, con un pizzico di zolfo. Infine, una spruzzata d’acqua asteroidale. Una volta procurati gli ingredienti, impastate bene il tutto in una grande ciotola fino a formare una palla rotonda, senza amalgamare troppo, e ponetela delicatamente nella fascia verde di abitabilità (detta Riccioli d’Oro) di una giovane stella. Scaldate a fuoco vivo, fino a che non diventa una bianca sfera incandescente, continuate a cuocere per qualche milione di anni, quindi lasciate raffreddare. Il colore virerà dal bianco al giallo al rosso fino a che non si formerà una crosta marrone dorata. Condite con una spruzzata d’acqua e un pizzico di composti organici. Mano a mano che l’acqua evapora, dando origine a nuvole e oceani, l’impasto si restringerà un poco. Lasciate riposare ancora qualche milione di anni e il pianeta Terra sarà pronto per chi saprà ereditarlo. Se siete fortunati, potrebbe formarsi sulla superficie del vostro nuovo mondo persino una sottile glassa di vita umana. A illustrare la Ricetta per cucinare altri pianeti come il nostro, è uno chef cinese di Chongqing, l’astronomo Li Zeng della Harvard University. Il “ristorante” dove l’ha messa a punto, è anche italiano, si trova infatti nelle europee Isole Canarie. È il Telescopio Nazionale Galileo dell’INAF, dov’è entrato in funzione ormai da due anni lo spettrometro HARPS-N, uno strumento di precisione per lo studio e la caratterizzazione dei pianeti extrasolari, il gemello dell’Eso piazzato in Cile. Grazie ai dati raccolti da HARPS-N sugli esopianeti più piccoli, con diametro inferiore a due volte quello della Terra, i ricercatori dello Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics sono riusciti a verificare che la formula per formare un pianeta simile al nostro è valida anche al di fuori del Sistema Solare. “Il nostro Sistema Solare non è così unico come potremmo pensare – rivela Courtney Dressing, del CfA, coordinatrice dello studio presentato a Seattle nel corso del 225esimo Meeting della AAS – a quanto pare, gli ingredienti di base dei pianeti extrasolari rocciosi sono sempre gli stessi”. Per giungere a queste deduzioni, sfruttando la precisione con la quale HARPS-N riesce a misurare la massa degli esopianeti, gli astronomi del CfA hanno messo fianco a fianco tutti i dieci pianeti extrasolari con diametro inferiore a 2.7 volte quello terrestre, per i quali sia disponibile una stima accurata della massa. Così facendo, hanno scoperto che i cinque pianeti con diametro inferiore a 1.6 volte quello della Terra, mostrano una forte correlazione tra la massa e le dimensioni; e che in una curva della densità si collocano sulla stessa linea di Venere e della Terra: il risultato suggerisce una composizione di ferro e roccia molto simile per tutti, a differenza di quanto emerso dai dati relativi agli esopianeti di massa superiore, le cui densità sono significativamente inferiori. “Se dunque vogliamo trovare un mondo davvero simile al nostro – osserva la Dressing – è sui pianeti con dimensioni inferiori a 1.6 volte quelle della Terra che dovremmo concentrarci, perché sono loro quelli rocciosi”.
Pianeti come Kepler-93b, l’ultimo in ordine di tempo caratterizzato dal team di HARPS-N. Il suo raggio è pari a circa una volta e mezza quello della Terra, e orbita molto vicino alla sua stella madre, con un periodo di rivoluzione di 4.7 giorni terrestri. Massa e composizione erano incerti, ma grazie a HARPS-N i ricercatori sono riusciti a stabilire che la massa è pari a 4.02 volte quella della Terra, e dunque a dedurne che la sua composizione dev’essere rocciosa. Quanto all’integrazione dei sistemi TNG e HARPS-N, il telescopio nazionale italiano da 3,6 metri e lo strumento che ha ereditato da Kepler l’onore e l’onere di tenere sott’occhio la porzione di cielo più battuta dai cacciatori di esopianeti, quella in direzione delle costellazioni del Cigno e della Lira, la Dressing, che ha avuto occasione di trascorrere un periodo al telescopio sull’Isola di La Palma, è entusiasta. “Fare parte del team di HARPS-N è fantastico – confessa la scienziata – sia per la qualità della scienza sia per l’esperienza anche culturale offerta dalla collaborazione internazionale”. Soddisfazione condivisa anche dal direttore del TNG, Emilio Molinari, primo tecnologo dell’INAF. “Ogni anno dedichiamo 80 notti per confermare i candidati esopianeti scoperti dalla sonda della Nasa, come il pianeta Kepler-93b appena identificato con questa ricerca – osserva Molinari – HARPS-N è uno strumento ad alta precisione che punta verso l’emisfero Nord, a differenza del suo predecessore e gemello montato all’Osservatorio dell’Eso in Cile. Il suo occhio permette di confermare la presenza degli esopianeti misurando il movimento che questi imprimono sulla loro stella con una precisione del metro al secondo”. Siamo soli nell’Universo? Per ottenere una risposta logica a una delle domande più interessanti che l’Umanità si sia posta, la Nasa ha pronta la sua squadra. Ma non pensate ai distaccamenti operativi protagonisti della lunga serie televisiva di Stargate dagli Usa alle varie galassie là fuori. Non ve n’è traccia all’Agenzia spaziale statunitense nè in Europa mentre in Italia la corruzione politica dilaga e la Democrazia parlamentare muore. Quello che la Nasa ha selezionato è un gruppo di ricerca interdisciplinare guidato dall’Università dell’Arizona, una vera e propria task force per la ricerca di vita aliena extraterrestre su mondi lontani dalla Terra. Una realtà probabile anche per la Santa Romana Apostolica Chiesa di Papa Francesco, gesuita e scienziato della Verità. Con NExSS, un istituto virtuale che raccoglie ricercatori di tutto il mondo, acronimo di “Nexus for Exoplanet System Science”, i giovani aiuteranno la Scienza a comprendere come pianeti simili alla Terra che abitiamo possano formarsi nell’orbita di stelle vicine. “La partecipazione al nuovo programma NExSS ci permetterà di capire come un pianeta possa ricavare la propria acqua, il carbonio, l’azoto durante il naturale processo di formazione – osserva Daniel Apai, team leader statunitense di “Earths in Other Solar Systems” – tutti quegli ingredienti che ci siamo abituati a considerare come fondamentali per creare una qualche opportunità di vita, altrove”. La Nasa conferma dunque il suo impegno in tema di ricerca della vita aliena extraterrestre. Dal lancio del Telescopio Spaziale Kepler sei anni fa, oltre 1900 pianeti extrasolari sono stati rilevati. Migliaia di altri candidati sono in attesa di conferma. La chiave di questo sforzo è capire come la biologia interagisca con l’atmosfera, la geologia, gli oceani e il corpo interno di un esopianeta, e come l’insieme delle interazioni fra questi elementi possa essere influenzato dalla stella ospite. NExSS raccoglie membri da una decina di università differenti, tre centri Nasa e due istituti di ricerca. Il team di EOS che comprende 25 ricercatori, seguirà 14 progetti di ricerca per combinare i risultati in un modello completo di formazione dei sistemi esoplanetari alieni, in grado di prevedere le connessioni tra proprietà dei sistemi e probabilità che ospitino esomondi simili alla Terra. Il team si avvarrà anche dei dati raccolti dal Large Binocular Telescope che vede la Chiesa Cattolica e gli astronomi gesuiti in prima linea. Grazie ai dati raccolti dal satellite Kepler, gli scienziati hanno scoperto migliaia di sistemi planetari extrasolari nella nostra Galassia, molti dei quali hanno più pianeti in orbita intorno alla singola stella ospite. Ora, analizzando questi sistemi esoplanetari, i ricercatori dell’Australian National University e del Niels Bohr Institute di Copenhagen hanno calcolato la percentuale di stelle della Via Lattea che possono ospitare pianeti nella zona verde abitabile. I risultati mostrano che miliardi di stelle possono avere da uno a tre pianeti nella zona abitabile, ovvero dov’è possibile trovare acqua allo stato liquido. Questo lavoro è stato pubblicato sulla rivista scientifica “Monthly Notices of the Royal Astronomical Society”. I pianeti che orbitano vicino alle proprie stelle avrebbero temperature troppo alte per ospitare la vita, così per scoprire se all’interno di quei sistemi è possibile trovare pianeti nella zona abitabile, un gruppo di ricercatori della Australian National University e del Niels Bohr Institute dell’Università di Copenaghen ha effettuato calcoli basati su una versione rivisitata di un metodo di 250 anni fa, la legge di Titius-Bode. Che risale circa al 1770 e ha permesso di calcolare la posizione di Urano prima che venisse scoperto. La legge di Titius-Bode stabilisce che esiste un rapporto preciso fra i periodi orbitali dei pianeti in un sistema planetario: il rapporto tra il periodo orbitale del primo e del secondo pianeta è uguale al rapporto tra il secondo e il terzo pianeta e così via. Pertanto, sapendo quanto tempo occorre ad alcuni pianeti per orbitare intorno alla propria stella, è possibile calcolare le orbite di altri pianeti nel sistema planetario. È inoltre possibile valutare se un pianeta manca nella sequenza prevista dalla legge di Titius-Bode.
“Abbiamo deciso di utilizzare questo metodo per calcolare le potenziali posizioni dei pianeti in 151 sistemi in cui il satellite Kepler aveva già trovato da 3 a 6 esopianeti – osserva Steffen Kjær Jacobsen, dottorando del gruppo di ricerca di Astrofisica e Scienze Planetarie al Niels Bohr Institute dell’Università di Copenaghen e co-autore della ricerca – in 124 di questi sistemi planetari la legge di Titius-Bode fornisce risultati corretti per la posizione dei pianeti, e abbiamo quindi cercato di utilizzarla per prevedere dove potessero trovarsi altri pianeti non ancora osservati. Per questo studio abbiamo selezionato solo i sistemi dove c’è una buona probabilità di poter osservare i pianeti mancanti con il satellite Kepler”. In 27 dei 151 sistemi planetari studiati, i pianeti alieni che erano stati osservati non si adattavano alla legge di Titius-Bode. I ricercatori hanno quindi cercato di collocare gli esomondi nelle posizioni previste dal modello, e quindi hanno aggiunto i pianeti che sembravano mancare tra quelli già noti. In questo modo hanno previsto un totale di 228 esopianeti in 151 sistemi solari alieni. “Abbiamo poi selezionato 77 pianeti in 40 sistemi planetari – spiega Steffen Kjær Jacobsen – poiché erano quelli con la più alta probabilità di transitare davanti alla stella ospite, e di essere quindi visti da Kepler. Abbiamo incoraggiato anche altri ricercatori a cercare questi esomondi. Se dovessimo trovarli, sarebbe un’indicazione che la teoria funziona”. I pianeti che orbitano molto vicino ad una stella sono troppo caldi. Di contro, pianeti troppo lontani dalla stella ospite sarebbero troppo freddi. La zona abitabile intermedia Riccioli d’Oro, dove c’è la possibilità di presenza di acqua liquida, non si trova ad una distanza fissa universale. La zona abitabile di un sistema planetario varia a seconda delle dimensioni e della luminosità della stella ospite. I ricercatori hanno stimato il numero di pianeti nella zona abitabile sulla base degli esomondi aggiunti utilizzando la legge di Titius-Bode, ottenendo un valore pari a 1-3 pianeti per ognuno dei 151 sistemi solari alieni studiati. A partire da questi 151, ora stanno procedendo ad un ulteriore controllo su 31 sistemi esoplanetari all’interno dei quali erano già presenti pianeti nella zona abitabile o dov’è stata necessaria l’aggiunta di un solo pianeta in più. “I nostri calcoli hanno mostrato che in questi 31 sistemi planetari c’era una media di due pianeti nella zona abitabile ciascuno – rivela Steffen Kjær Jacobsen – secondo le statistiche e le indicazioni che abbiamo, buona parte dei pianeti presenti nella zona abitabile sarà composta da pianeti solidi, su cui potremmo trovare acqua allo stato liquido e dove la vita potrebbe esistere”. Se poi si estendono questi calcoli a regioni più vaste, questo risultato indica che solo nella nostra Galassia possono esistere miliardi di stelle con pianeti nella zona abitabile. Steffen Kjær Jacobsen osserva che il prossimo passo è di incoraggiare altri ricercatori ad analizzare nuovamente i dati del Telescopio Spaziale Keplero per i 40 sistemi esoplanetari che sembrano ben posizionati per le osservazioni con il satellite redivivo. Se un giorno l’Umanità dovrà vivere su un altro esomondo al di fuori del Sistema Solare terrestre, come sembra suggerire il film Interstellar, è probabile che potrà trovare un clima un po’ diverso, sicuramente più pazzo di quello terrestre modificato dall’inquinamento umano, e questo a causa di qualche movimento orbitale e gravitazionale insolito, magari indotto da diverse lune, pianeti e stelle del sistema solare alieno. Una nuova ricerca firmata da Rory Barnes, astronomo dell’Università di Washington, pubblicata su “The Astrophysical Journal”, descrive possibili sistemi planetari in cui un “colpetto” gravitazionale alla Interstellar, potrebbe avere un effetto devastante sull’orbita e sul clima di un altro esopianeta vicino e possibilmente abitabile. L’entità del caos climatico può variare ampiamente in base all’orbita dei pianeti che possono rimanere circolari o prendere invece, all’improvviso, una forma ellittica e allungata tanto da metterli a rischio di scontrarsi con la propria stella madre, il che sarebbe davvero un cambiamento climatico drammatico oltre che distruttivo per le future colonie terrestri. È noto che buona parte delle caratteristiche climatiche di un pianeta sono condizionate dall’orbita e dalla vicinanza o lontananza dalla stella madre e da altri oggetti colossali come massicce esolune. E proprio l’orbita di un esopianeta potrebbe essere talmente bizzarra da inibire addirittura la vita o renderlo improvvisamente sterile, semmai su quella esoterra fosse apparsa la vita a un certo punto della sua evoluzione. Lo studio del team guidato da Barnes si è soffermato in particolare su un effetto chiamato “mean motion resonance”, ossia risonanza di moto medio, un particolare tipo di risonanza orbitale che può causare instabilità e portare letteralmente all’espulsione dal sistema solare di uno dei corpi coinvolti. Questo effetto entra in gioco quando i periodi orbitali di due pianeti sono in un rapporto di numeri interi. Nel corso di milioni di anni, quindi molto lentamente, le forze gravitazionali possono influenzare le orbite dei corpi attorno alla stella. Questo può accadere anche a un pianeta che si trova all’interno della zona abitabile del sistema planetario, dove potrebbe esistere la vita, e che all’improvviso subisce un “tilt”, un cambio drastico della sua orbita che può durare anche milioni di anni. Barnes definisce questi pianeti “terre caotiche”, il che non li rende dei perfetti candidati per ospitare o per aver ospitato in passato qualche forma di vita aliena. Si può parlare quasi di bullismo planetario o di prepotenza gravitazionale orbitale, soprattutto quando si presenta un’altra condizione studiata dagli scienziati: l’inclinazione reciproca, il che significa che le orbite dei due pianeti sono quasi perpendicolari l’una rispetto all’altra. Nel nostro Sistema Solare, grazie a Dio, non si verifica questo fenomeno, perché i pianeti si trovano tutti sullo stesso piano nello spazio e per questo sono chiamati complanari. È una caratteristica che non si ripete in tutti i sistemi planetari. Per studiarli Barnes e colleghi hanno deciso di ricreare questi “tilt” orbitali al computer. “Quello che abbiamo trovato – rivela lo scienziato – è che tutto viene sconvolto. Quelle piccole perturbazioni che si verificano nel corso del tempo sempre allo stesso punto, causano dei cambiamenti pazzeschi all’orbita che può anche capovolgersi completamente per poi tornare dov’era prima. È stato abbastanza inaspettato per noi”. Non è detto che questi esopianeti siano inabitabili o che non lo siano mai stati, soprattutto perché questi cambiamenti gravitazionali possono essere talmente lievi e spalmati nel tempo da non determinare uno sconvolgimento orbitale tanto drammatico per una civiltà aliena. Al contrario, se questi tilt fossero tanto drastici da cambiare in qualche secolo il clima dell’esopianeta, allora sarebbe meglio che gli astronomi cerchino altrove dei pianeti extrasolari abitabili e che l’Umanità si prepari ad affrontare una probabile invasione aliena extraterrestre con migrazioni di massa da esomondi morenti! Conferme e novità su questo campo di studi in futuro potrebbero venire dal James Webb Space Telescope, tanto potente da determinare fra qualche anno la composizione delle atmosfere degli esopianeti. “Segnali di vita nei cortili e nelle case all’imbrunire, le luci fanno ricordare le meccaniche celesti”, canta Franco Battiato. I segnali di vita aliena su un esopianeta, in una galassia vicina o lontana, dove si trovano? “Se c’è vita ET là fuori, ed è facile che ci sia, la scopriremo sfocata e timida, illuminata dalla luce di una stella, nell’atmosfera esoplanetaria di un’altra Terra”, è la strenua difesa di Sara Seager, cacciatrice di esopianeti al Massachusetts Institute of Technology, e del fisico William Bains sulle pagine di “Science Advanced”.
L’atmosfera aliena, prima di tutto! L’impronta chiara, evidente e distinta della vita extraterrestre è nei gas che compongono il cielo dei pianeti extrasolari. Se il metabolismo degli organismi è in grado di alterare le componenti di un’atmosfera, una spettroscopia ad altissima risoluzione può essere risolutiva. Uno spettro di un’atmosfera aliena può rivelare la presenza di molecole di anidride carbonica, acqua, ozono, metano, ammoniaca e marcatori di sviluppo industriale nucleare. Bio-impronte di cui sempre più bisogna andare in caccia, sperando che i referendum anti-nucleari alieni siano davvero rari come le Esposizioni Universali prive di senso! Negli ultimi vent’anni gli scienziati hanno scoperto oltre 5500 nuovi esopianeti. Il sogno di un altro esomondo capace di ospitare la vita in qualche remoto punto della Galassia e dell’Universo ha un fascino irresistibile indipendente dalla fantascienza. Ricercatori e astrofisici sono in cerca di esopianeti simili alla Terra per dimensioni, temperatura, massa e gravità, possibilmente all’interno della zona abitabile. L’acqua e la vita possono trovarsi anche su SuperTerre che orbitano fuori dalla zona abitabile, a distanze dieci volte superiori di quelle che separano la Terra dalla sua stella, il Sole. A patto che le atmosfere di questi esomondi contengano idrogeno gassoso a sufficienza, e quindi un effetto serra e un campo magnetico potenti, ossia capaci di mantenere il calore all’interno dell’atmosfera e di creare un clima mite nonostante le poche radiazioni ricevute in superficie. Allo stesso modo anche pianeti aridi e più vicini alle proprie stelle madri possono avere bisogno di una quantità minore di acqua per creare la vita, vista l’alta umidità atmosferica. Ogni molecola assorbe la luce in maniera diversa. È così che gli astronomi, osservando come l’atmosfera di un pianeta extrasolare assorbe la luce della sua stella, possono identificare di quali molecole siano composti i cieli dei mondi alieni. Dunque, “concetriamoci sulle atmosfere”, insistono gli scienziati Seager e Bains. Il problema principale resta la nostra oggettiva incapacità tecnologica di determinare le caratteristiche di un pianeta lontano anni luce. Al di là di massa, raggio e quantità di luce ricevuta, non esistono come in Star Trek sensori per analizzare in maniera esaustiva né atmosfera né superficie nè geologia dei pianeti alieni. Il James Webb Space Telescope della Nasa potrà certo dire qualcosa di più su questi mondi lontani. Ma non farà miracoli. Bisogna costruire astronavi interstellari per esplorare l’Universo direttamente. Altrimenti l’Umanità è già condannata all’estinzione naturale. Nel frattempo hanno ragione coloro che ritengono prematuro, se non completamente superfluo, mettere in discussione il concetto di zona abitabile così com’è formulate. Finché non ci sono tecnologie disponibili ed efficienti, quello della zona abitabile resta il migliore dei ragionamenti possibili. Alle eso-atmosfere aliene bisogna quindi prestare sempre più attenzione su tutte le frequenze, per dirla alla Star Trek! Non si tratta di una trovata pubblicitaria. Il logo dell’Agenzia spaziale statunitense è originale. La direzione del Jet Propulsion Laboratory conferma tutto a mezzo stampa. È la comunicazione della Scienza grazie alla bellezza della Space Art che ammiriamo in artisti spaziali italiani come il compianto Italo Rodomonti. La Nasa stavolta sorprende ancora una volta con ironia e paradosso, grazie a una campagna di comunicazione senza precedenti. “Per chi ha preso a noia spiagge tropicali e località esotiche, ecco un pacchetto vacanze che brucia la concorrenza, sostengono scherzando gli scienziati del JPL su Planet Quest, il portale Nasa dedicato al programma di esplorazione esoplanetaria, con mete, è il caso di dirlo, letteralmente da brivido: gli esomondi Kepler 16B, HD40307G e Kepler 186F, decisamente lontanissimi per le capsule Orion, Soyuz e i razzi chimici, esopianeti forse potenzialmente abitabili. Per rendere tutto più credibile i grafici Nasa hanno disegnato tre poster pubblicitari, dal gusto classico Anni ’50 alla Flash Gordon, che raccontano con un sorriso le sorprendenti scoperte compiute in questi 20 anni di caccia ai pianeti extrasolari. Immagini vintage, registro ammiccante e addirittura un sedicente Ente del Turismo Esoplanetario inventato dalla Nasa per l’occasione. I frutti della Libertà che si respira negli States. Provate la forza di gravità di una SuperTerra, recita il primo manifesto. Due volte più grande del nostro pianeta, in termini di volume, HD40307G sta a cavallo fra una maxi Terra e un piccolo Nettuno. Gli astrofisici non sanno ancora se la superficie di questo esopianeta sia rocciosa o nascosta da strati e strati di gas ghiacciato come nel film Interstellar, ma su una cosa non hanno dubbi: la forza di gravità qui è molto più forte dal momento che parliamo di un corpo celeste di massa otto volte superiore a quella terrestre! Il secondo poster invita a rilassarsi su Kepler 16B dove persino la nostra ombra trova buona compagnia. Proprio come Tatooine, patria di Luke Skywalker in Star Wars di Lucas, Kepler 16B orbita attorno a una coppia di stelle. Due Soli significa due ombre. E non fatevi ingannare dalla raffigurazione amichevole del pianeta alieno. Kepler 16B potrebbe anche essere un gigante gassoso come Saturno. Tramonti mozzafiato ma abitabilità deludente o scarsa: la temperatura superficiale è simile a quella del ghiaccio secco! Il terzo e ultimo manifesto della Nasa recita: “Kepler 186F, là dove l’erba del vicino è sempre più rossa”.
Primo esopianeta di dimensioni simili a quelle terrestri ad essere stato scoperto attorno a un’altra stella, nell’orbita di quella che è considerata la fascia di abitabilità, Kepler 186F non gode del calore tiepido regalatoci dalla nostra stella, il Sole. Qui la luce è più fresca, tanto che il processo fotosintetico darebbe vita a una vegetazione rossastra! Prima di fare le valigie, insomma, leggete molto attentamente le clausole scritte in piccolo e inventate la vostra navetta spaziale interstellare privata grazie alla liberalizzazione dell’industria cosmica in corso d’opera negli Usa: tema degno di un vero Expo anche negli Stati Uniti di Europa insieme alla Santa Russia. Tre pianeti di dimensioni paragonabili a quella della Terra sono stati individuati nell’orbita di una fresca stella nana rossa dal cacciatore di esopianeti, il Telescopio Spaziale Kepler. EPIC 201367065 è una nana rossa di classe M, la più fredda, ha circa la metà delle dimensioni e della massa del nostro Sole ed è situata ad appena 150 anni luce dalla Terra, tra le prime 10 stelle più vicine note per avere pianeti in transito. Un astro abbastanza luminoso da permettere agli astronomi di studiarne le atmosfere dei pianeti in transito determinandone se la composizione sia favorevole o meno alla vita. “Una sottile atmosfera fatta di azoto e ossigeno ha permesso alla vita di prosperare sulla Terra. Ma la natura è piena di sorprese – osserva Ian Crossfield, l’astronomo dell’Università dell’Arizona che ha condotto lo studio per “The Astrophysical Journal” – molti pianeti extrasolari scoperti dalla missione Kepler sono avvolti da atmosfere composte da uno spesso strato di idrogeno incompatibile con la vita come noi la conosciamo”. I tre esopianeti sono 2.1, 1.7, e 1.5 volte le dimensioni della Terra. Il pianeta più esterno, una volta e mezzo il raggio terrestre, è il più piccolo del gruppo e orbita abbastanza lontano dalla sua stella, ricevendo livelli di luce solare paragonabili a quelli che riceve la Terra dal Sole. Gli autori dello studio hanno calcolato che i tre esomondi ricevono 10.5, 3.2 e 1.4 volte l’intensità luminosa che riceve la Terra. “La maggior parte dei pianeti che abbiamo trovato fino ad oggi sono troppo caldi, incandescenti a volte – rivela Erik Petigura – questo sistema sembra essere il più vicino con pianeti a temperatura moderata. C’è una possibilità molto reale che il pianeta più esterno sia roccioso come la Terra, il che significa che questo esomondo potrebbe avere la giusta temperatura per sostenere oceani di acqua liquida”. Per Andrew Howard dell’Università delle Hawaii (Usa), “i pianeti delle dimensioni e della temperatura della Terra sono comuni nella nostra Via Lattea. Abbiamo anche scoperto alcuni pianeti delle dimensioni della Terra che sembrano essere fatti degli stessi materiali, per lo più di roccia e ferro”. Benché l’attività più conosciuta sia quella di cercare segnali di intelligenza extraterrestre, da cui l’acronimo SETI, ossia “Search for ExtraTerrestrial Intelligence”, l’istituto di ricerca statunitense si occupa attivamente anche di vita extraterrestre non necessariamente intelligente. Al Carl Sagan Center del SETI Institute vengono condotte ricerche nel campo dell’astrobiologia, lo studio della vita nell’Universo. Un gruppo di ricerca guidato da Hiroshi Imanaka, specialista nella chimica delle atmosfere planetarie, è stato di recente selezionato per entrare nella squadra di NExSS (Nexus for Exoplanet System Science), una nuova iniziativa della Nasa per affrontare in maniera collaborativa il problema e la soluzione di trovare vita aliena su pianeti attorno ad altre stelle. “Uno dei traguardi più rilevanti conseguiti dalla comunità scientifica che si occupa di esopianeti è stato quello di trovare mondi orbitanti nella cosiddetta zona abitabile – osserva Imanaka – ovvero in quell’intervallo di distanze da una stella in cui un pianeta potrebbe avere temperature tali da permettere l’esistenza di oceani liquidi.
Tuttavia, la presenza di abbondante acqua allo stato liquido non è l’unica condizione necessaria allo sviluppo e all’esistenza della vita. Alcune delle lune di Giove e Saturno sono esempi di luoghi che non risiedono nella zona abitabile convenzionale, ma che potrebbero comunque essere abitabili. Ora, il nostro obbiettivo è di prendere ulteriori misure per caratterizzare gli ambienti abitabili che si trovano al di là del Sistema Solare”. Lo studio dei pianeti intorno ad altre stelle, i cosiddetti esopianeti, è un campo relativamente nuovo. La scoperta del primo esopianeta attorno a una stella simile al Sole risale solo a vent’anni fa. Da allora, grazie soprattutto ad alcuni strumenti dedicati come il satellite Kepler della Nasa, ne sono stati scoperti quasi 6mila, comprese le svariate migliaia di candidati in attesa di essere confermati. È stata proprio questa repentina e affollata irruzione sul palcoscenico scientifico dell’Astronomia, che ha spronato gli sforzi per stabilire se qualcuno di questi esopianeti presenti indizi di attività biologica e industriale, come la presenza di ossigeno e di metano nelle loro atmosfere. La scoperta di pianeti extrasolari è stato un lavoro fatto in gran parte dagli astronomi, ma sono gli scienziati planetari e gli astrobiologi che hanno l’esperienza necessaria per caratterizzare ambienti planetari ed esaminarli per la biologia. In questo contesto, l’intento della collaborazione NExSS è quello di mettere assieme le competenze degli astronomi, che scoprono gli esopianeti, con quelle di planetologi ed esobiologi, che descrivono le loro caratteristiche, magari insieme ai testimoni di incontri ravvicinati con alieni in carne e ossa sulla Terra. Quindi unire questi tre approcci scientifici non semplicemente per trovare pianeti extrasolari, ma per determinare se ospitano la vita. Risulta allora evidente il ruolo degli astrobiologi SETI in questo sforzo congiunto. Imanaka e colleghi hanno studiato approfonditamente un mondo del nostro Sistema Solare che potrebbe fornire utili indizi per esopianeti simili: Titano, la più grande luna di Saturno. “Abbiamo studiato a lungo la chimica organica di questa luna intrigante – rivela Imanaka – avvolta in una spessa atmosfera nebbiosa sotto cui sappiamo esserci laghi di metano liquido ed etano”. Naturalmente è alquanto improbabile che nei laghi di Titano prosperino delle forme di vita extraterrestre, pur microbiche, benché recentemente sia stato messo a punto un modello biologico, differente da quello terrestre, perfetto per quei gelidi idrocarburi che custodiamo allo stato liquido compresso negli accendini cinesi e nelle bombole di gas. Si può considerare Titano come un buon candidato per un esopianeta alieno che possa ospitare la vita? “È anche possibile che Titano ospiti forme di vita, o comunque non posso negarlo con certezza – spiega Imanaka – ma quel che è certo e interessante per noi è che Titano può insegnarci molto su un mondo prebiotico, poiché lì vengono prodotti i composti organici più complessi noti al di fuori della Terra. E grazie alle sue temperature estremamente basse temperature, tutte le reazioni chimiche su Titano sono lente. È un mondo al rallentatore e proprio per questo motivo ci può dire qualcosa sulle condizioni della Terra primordiale e forse anche su alcuni pianeti extrasolari.
Far parte della rete NExSS ci permette di applicare la nostra profonda conoscenza di Titano all’esame delle atmosfere di pianeti extrasolari nebbiosi, che potrebbero risultare simili”. Che il nostro Sistema Solare sia una specie di rarità resa meno tale solo dal Dono di Dio e dal gran numero di stelle che esistono nell’Universo, lo si evince mano mano che gruppi di astronomi rilevano sempre nuove realtà aliene che magari possono comporsi e trovare un equilibrio vitale alternativo al nostro. È questo di fatto il quesito che si sono posti i ricercatori autori di una recente ricerca, pubblicata su “The Astronomical Journal”, che si è avvalsa del Palomar Observatory utilizzando due nuove tecnologie adattive ottiche in grado di compensare gli effetti di sfocatura dell’atmosfera terrestre: il sistema di ottica adattiva Robo-AO robotico, sviluppato sotto la guida di Christoph Baranec della University of Hawaii all’Istituto di Manoa per Astronomia, e l’estrema sistema di ottica adattiva PALM-3000, sviluppato da un team di Caltech e Jet Propulsion Laboratory della Nasa. L’obiettivo era di approfondire le conoscenze sulle influenze di più stelle su pianeti extrasolari: per farlo gli scienziati hanno preso in esame un pianeta in un sistema a quattro stelle, il secondo multiplo ad oggi conosciuto. Il sistema solare alieno, denominato 30 Ari, si trova a 136 anni luce di distanza nella costellazione dell’Ariete. Il pianeta del sistema è un gigante gassoso 10 volte la massa di Giove, che orbita intorno alla sua stella primaria, una piccola nana rossa, ogni 335 giorni, quasi un anno terrestre. Il sistema ET era già conosciuto ma si riteneva composto di tre sole stelle. “Circa il 4 percento delle stelle simili al nostro Sole si trovano in sistemi quadruple – rivela Andrei Tokovinin del Cerro Tololo Inter-American Observatory in Cile – un dato maggiore delle stime precedenti, che è stato reso possibile grazie al miglioramento delle tecniche di osservazione”. La quarta stella appena scoperta, la cui distanza dal pianeta è 23 volte l’Unità Astronomica Terra-Sole, non sembra aver influenzato l’orbita dell’esomondo. E perché questo non sia successo al momento non è chiaro, tanto che il team di ricercatori ha in programma ulteriori osservazioni per capire meglio l’orbita della stella appena scoperta e le sue complicate dinamiche familiari. Al di là degli aspetti scientifici indubbiamente prioritari, il cielo alieno del pianeta gassoso potrebbe regalare un pizzico di più di quel fascino già ineguagliabile che la nostra finestra terrestre dona ogni notte senza nubi in montagna, mettendo in mostra miliardi di stelle della Via Lattea. Sicuramente quel cielo alieno apparirebbe bizzarro: un Sole, due stelle tanto vicine e brillanti da essere visibili anche di giorno, e una di queste stelle che di notte, magari al telescopio, si mostra per quello che è, un sistema binario, due stelle che orbitano una con l’altra.
Superata la fascinazione di come potrebbe apparire il sistema solare Ari 30, resta l’obiettivo scientifico che l’autore principale dello studio Lewis Roberts del Nasa-JPL e colleghi cercano di ottenere: comprendere gli effetti che più stelle possono avere sulla formazione e lo sviluppo dei pianeti. I risultati suggeriscono che i compagni stellari possano influenzare il destino degli esomondi cambiando le loro orbite e spingendoli a crescere. Si spiegherebbe così il motivo per cui i “Giove caldi” (Hot Jupiter) possano avere orbite strette rispetto alla stella primaria, perché influenzati gravitazionalmente da compagni stellari. “Questo risultato rafforza il collegamento tra sistemi stellari multipli e la presenza di pianeti massicci”, osserva Roberts. Ufficialmente partito nell’Agosto del 2012 con l’entrata in funzione dello strumento HARPS-N, il programma di osservazione INAF per la caratterizzazione dei sistemi planetari, il “Global Architecture of Planetary Systems – GAPS”, sta ottenendo risultati sorprendenti. La sensibilità di HARPS-N, spettrometro cacciatore di pianeti dell’emisfero boreale montato al Telescopio Nazionale Galileo, è stata utilizzata per rivedere alcune caratteristiche di un sistema planetario già noto per essere composto da una stella 3-4 volte più luminosa del Sole, posta a circa 1400 anni luce dalla Terra, nella costellazione di Ercole, e un pianeta, TrES-4b, identificato nel 2007 utilizzando il metodo dei transiti nell’ambito del “Trans-Atlantic Exoplanet Survey”. Il pianeta allora risultò essere in un’orbita molto stretta con un periodo di circa 3,5 giorni e un diametro pari a quasi il doppio di quello di Giove ma una massa di poco inferiore a esso. Questo ne fece, tra gli esopianeti noti al momento della scoperta, uno di quelli di maggiori dimensioni e di minima densità. L’esomondo TrES-4b appartiene alla categoria denominata “Hot Jupiter”. Uno studio successivo determinò inoltre la natura binaria della stella madre. Il team di GAPS, guidato da Alessandro Sozzetti dell’Inaf di Torino, che ha pubblicato il nuovo risultato su A&A, aveva inserito TrES-4b nella lista di quei sistemi planetari noti da sondare più in dettaglio, a caccia di nuovi esopianeti in orbite più esterne. Ma, invece di trovargli una massa planetaria compagna, il gruppo di astronomi lo ha alleggerito! Ossia, nessuna nuova rilevazione, ma la conclusione che l’esopianeta ha una massa due volte minore di quella precedentemente misurata. L’estrema precisione di HARPS-N nel determinare l’ampiezza delle variazioni di velocità radiale indotte dall’azione gravitazionale del pianeta sulla stella madre, ha permesso, infatti, di attribuire tali variazioni a un esomondo molto meno massiccio di quanto si pensasse. Così, benchè voluminoso, l’esopianeta si è decisamente smagrito perchè la sua massa si è ridotta della metà. Così lavora la Scienza. TrES-4b era già entrato di merito in quella dozzina di esopianeti noti per avere i raggi più grandi.
Ma ora, essendo ancora meno massiccio di quanto si pensava, merita il podio nella categoria dei “puffy planets”, ossia tra i pianeti più voluminosi a bassissima densità. Medaglia speciale per TrES-4b che diventa il secondo oggetto meno denso in assoluto a oggi noto, con una massa poco meno della metà di quella di Giove e un raggio di 1,84 gioviani. Con al primo posto ancora WASP-17b per i suoi 1,93 raggi gioviani con massa comparabile. Potrebbe tranquillamente galleggiare sul mare, ammesso che se ne trovasse uno così enorme da contenerlo! “Questa è una delle tante sfide che la Scienza ci pone – osserva Alessandro Sozzetti – sui pianeti extrasolari c’è ancora tantissimo da scoprire e, quindi, da capire. In questo caso particolare dobbiamo comprendere come questi Giovi caldi siano così rigonfi. Al di là delle cause, ancora tutte da accertare, che hanno portato in passato a una misura della massa parecchio maggiore rispetto a quella da noi oggi rilevata, c’è da risolvere la questione di come si siano formati tali corpi celesti. Noi sappiamo che un pianeta gassoso più è caldo, più si gonfia per un effetto di espansione. Ma il forte irraggiamento a cui sono sottoposti gli Hot Jupiter non è sufficiente a spiegare casi estremi come quello di TrES-4b, che ha una densità 15 volte inferiore a quella di Giove. Con buone probabilità la risposta sta nei dettagli, ancora sconosciuti, della formazione, composizione ed evoluzione di questi oggetti. A vent’anni dalla scoperta del primo Hot Jupiter attorno alla stella 51Pegasi, per molti versi siamo ancora solo all’inizio del cammino verso la comprensione di quest’affascinante classe di sistemi planetari”. Il Programma di osservazione GAPS continua mentre gli astrosismologi ricercatori dell’Università di Birmingham hanno guidato il team che si è attribuito la scoperta di un sistema solare alieno con cinque pianeti di dimensioni simili alla Terra, che risale agli albori della formazione della Via Lattea, la Galassia che abitiamo. Il merito è ancora una volta della missione Kepler della Nasa. Sulle colonne di “The Astrophysical Journal” è giunta la notizia di una stella del tutto simile al nostro Sole, Kepler-444, attorno a cui potrebbero ruotare cinque pianeti di dimensioni comprese fra Venere e Mercurio. Kepler-444 è una stella formatasi 11,2 miliardi di anni fa, al tempo in cui l’Universo aveva meno del 20 percento della sua età attuale. Di fatto è il più antico sistema solare alieno conosciuto a presentare caratteristiche tanto simili a quello che ben conosciamo: cinque pianeti di dimensioni paragonabili alla Terra. “Questo sistema è estremamente peculiare anche dal punto di vista della compattezza – spiega Alessandro Sozzetti dell’Osservatorio Astrofisico Inaf di Torino, fra gli autori dell’articolo con un altro italiano, Andrea Miglio, associato dell’Osservatorio Astronomico Inaf di Padova – i cinque pianeti si trovano tutti su orbite di piccole dimensioni, meno di un quinto dell’orbita di Mercurio. Indice di una forte evoluzione dinamica del sistema, successiva alla sua formazione. Appena l’un percento dei sistemi extrasolari individuati da Kepler ha caratteristiche simili a quelle di Kepler-444”. Il team di ricercatori si è avvalso delle conoscenze astrosismologiche maturate negli ultimi decenni: dalla frequenze delle oscillazioni naturali della stella, causate da onde sonore intrappolate in una cavità risonante situata al suo interno, è possibile calcolare raggio, massa e, soprattutto, età dell’astro. Per l’individuazione degli esopianeti, invece, si ricorre al metodo dei transiti che causano oscuramenti più o meno estesi del disco stellare. L’affievolimento nell’intensità della luce ricevuta dall’astro consente agli scienziati di desumere la dimensione esatta degli esomondi partendo dalle specifiche della stella ospite. Tiago Campante della School of Physics and Astronomy dell’Università di Birmingham, primo autore dell’articolo, spiega come questa scoperta possa aprire finestre molto importanti sulla teoria della formazione dei sistemi planetari alieni: “adesso sappiamo che i pianeti di dimensioni simili a quelli della Terra si sono formati durante l’intera storia dell’Universo (13,8 miliardi di anni): non sono pochi per escludere che la Galassia abbia già ospitato altre forme di vita nel suo passato”, magari come la nostra qui sulla Terra. C’è da tener conto del fatto che al momento in cui la Terra si è formata, i pianeti di questo antico sistema solare erano già più vecchi di quanto non lo sia il nostro pianeta oggi. Ma certo è che la scoperta fatta dagli astrosismologi aggiunge elementi utili a fissare un inizio universale ai processi di formazione planetaria nella Galassia e altrove, quindi della probabile esistenza di antiche civiltà aliene. Secondo il professor Bill Chaplin dell’Università di Birmingham e leader del gruppo che nell’ambito della missione Kepler si è occupato delle stelle di tipo solare, “la scoperta di pianeti extrasolari in orbita attorno a stelle simili alla nostra, ci spinge a continuare la ricerca di pianeti simili alla Terra nelle immediate vicinanze del nostro Sistema Solare”. Le implicazioni sono notevoli.
“Questo eccezionale risultato consolida le potenzialità dell’astrosismologia nella determinazione dei parametri fisici delle stelle – spiega Ennio Poretti dell’Osservatorio Astronomico Inaf di Brera – come ha dimostrato il caso di Kepler-444, la precisa determinazione di massa e raggio delle stelle ospiti ha un’immediata ricaduta sulla conoscenza degli stessi parametri dei pianeti. La missione Esa PLATO 2.0 è basata su questo connubio maturato negli anni proprio tramite le missioni CoRoT e Kepler. Ma ancor più significativo è l’uso dell’astrosismologia per rivelare quel dato che le stelle ostinatamente tendono a nascondere, la loro età”. Cercare pianeti extrasolari non è certo facile dalla Terra, in mancanza di vere astronavi interstellari frutto della liberalizzazione dell’impresa spaziale privata. Individuare poi gli esomondi simili per composizione, massa e gravità alla Terra, lo è ancora di più. Se poi restringiamo ancora di più le indagini alle sole esoterre nella fascia abitabile, la faccenda si complica ulteriormente. Possiamo solo sperare nei Vulcaniani immortalati dal compianto Leonard Nimoy. Tra i tanti limiti osservativi con cui devono necessariamente fare i conti gli astronomi nelle loro indagini spaziali, specie per l’osservazione diretta degli esopianeti, uno può essere determinante: la fastidiosa presenza di finissime polveri attorno alle loro stelle madri. Essa è presente in ogni sistema planetario ma, se eccessiva, può rendere impossibile l’individuazione degli esopianeti. Per capire quanta polvere ci sia attorno a sistemi potenzialmente favorevoli ad ospitare esoterre e la sua distribuzione, specie nella loro zona di abitabilità, oggi gli astronomi dispongono di un’arma in più: lo strumento “LBT Interferometer” installato al Large Binocular Telescope in Arizona, di cui l’Italia con l’Inaf e il Vaticano è uno dei partner internazionali. Il sensore LBTI combina i segnali raccolti da ciascuno dei due specchi principali da 8,4 metri di diametro dell’Osservatorio per ottenere immagini dettagliatissime nell’infrarosso, banda dove viene prodotta la maggiore quantità di radiazione dalla polvere interplanetaria di sistemi extrasolari. Per la prima volta questo strumento è stato testato per indagare la distribuzione della polvere nel sistema di Eta Corvi, una stella di taglia solare, nota per essere insolitamente polverosa con una quantità di particelle 10mila volte superiore a quella presente nel nostro Sistema Solare. Una proprietà forse dovuta a un recente impatto tra corpi celesti nelle regioni più prossime alla stella. I risultati, pubblicati in un articolo sulla rivista “The Astrophysical Journal”, indicano che, grazie all’ottimo funzionamento del sensore LBTI, la polvere appare molto più vicina alla stella di quanto di pensasse, disponendosi tra l’astro e la sua zona di abitabilità. “Con LBTI siamo finalmente in grado di sapere come si distribuisce la polvere attorno alle stelle – rivela Phil Hinz, “principal investigator” dello strumento – Eta Corvi non è un buon candidato per osservazioni dirette di eventuali esopianeti in orbita attorno ad essa, ma ci dimostra le qualità di LBTI: stiamo iniziando a capire la struttura dei sistemi planetari come mai prima d’ora”. Inoltre “LBT è un telescopio unico al mondo, disegnato per lavorare in interferometria – osserva Adriano Fontana dell’Inaf, responsabile del centro italiano delle osservazioni – e questo risultato è da una parte la realizzazione di un sogno iniziato molti anni fa, dall’altro solo l’inizio di una serie di risultati scientifici che ci aspettano dall’utilizzo di questa tecnologia”. Il primo a scoprire il satellite naturale Io, una delle lune di Giove, fu Galileo Galilei nel 1610 con il suo cannocchiale. In quel rudimentale strumento, Io e gli altri tre corpi celesti che lo scienziato cattolico toscano ribattezzò Astri Medicei in onore di Cosimo II De’ Medici all’epoca Granduca di Toscana, apparivano come piccoli puntini luminosi. Quattro secoli dopo, gli scienziati sono riusciti a osservare straordinari dettagli di quel mondo alieno lontano, grande come la nostra Luna ma oltre mille volte più distante, una vera miniera a cielo aperto, ricca di ogni ben di Dio. A riuscire nell’impresa “trek”, spingendosi fin dove mai un telescopio terrestre era giunto prima, è il Large Binocular Telescope in Arizona. Le immagini raccolte hanno sfruttato due delle caratteristiche che rendono unico LBT. In primis, la sua naturale predisposizione per l’interferometria grazie ai due specchi principali da 8,4 metri di diametro di cui è dotato, installati su un’unica montatura. La luce di Io raccolta da ciascuno dei due specchi è stata combinata in modalità interferometrica all’interno dello strumento Large Binocular Telescope Interferometer, così che la risoluzione finale delle immagini elaborate non è quella ottenibile dai singoli telescopi, ma quella che si avrebbe con un telescopio equipaggiato di un solo specchio principale di ben 23 metri di diametro, ovvero la distanza tra i bordi dei singoli specchi primari di LBT. Poi, l’ottica adattiva che ha permesso di annullare quasi completamente gli effetti negativi della turbolenza atmosferica sulle riprese. A queste si è aggiunta una sofisticata tecnica di integrazione ed elaborazione delle immagini, che ha permesso di ottenere una visione di Io senza precedenti. “In questo studio abbiamo utilizzato molta tecnologia e tecniche sviluppate in Italia – rivela Carmelo Arcidiacono, ricercatore Inaf tra i coautori dell’articolo pubblicato su Astronomical Journal che presenta i risultati di queste osservazioni guidate da Al Conrad del Large Binocular Telescope Observatory – mi riferisco alla coppia composta dagli specchi secondari adattivi di LBT e dai sensori di fronte d’onda a piramide, elementi principali del sistema di ottica adattiva dello strumento, e alle tecniche di deconvoluzione e ricostruzione delle immagini sviluppate all’Università di Genova appositamente per LBT”. La sinergia tra la potenza del sistema di ottica adattiva e la raffinatezza del software di ricostruzione delle immagini, ottenute nella banda del vicino/medio infrarosso dalla LMIRcam (Lbti Mid-Infrared camera) ha permesso così al team di studiare con un dettaglio senza precedenti l’attività vulcanica di Io, il corpo geologicamente più attivo del Sistema Solare, assolutamente da conquistare con una missione mineraria spaziale privata. Un primato dovuto alle enormi forze mareali prodotte dall’interazione gravitazionale del satellite Io con Giove. Le immagini ottenute da ben 450 milioni di chilometri di distanza da Io, hanno una risoluzione pari a 100 Km sulla superficie della luna gioviana. Grazie a questa vista d’aquila è stata identificata l’attività eruttiva in 14 siti già noti delle riprese delle sonde Voyager 1, 2 e Galileo, ma soprattutto sono stati scoperti due nuovi vulcani. “Ancora più interessante è il caso del Loki Patera, il vulcano più potente del Sistema solare, che abbiamo super-risolto spingendoci a un livello di dettaglio di circa 40 Km grazie all’analisi delle immagini prodotte tramite deconvoluzione e ricostruzione delle originali – spiega Arcidiacono – in questo caso abbiamo identificato la caratteristica forma a ferro di cavallo del lago di lava. Ma siamo andati oltre, ricostruendo lo stato di avanzamento del fronte lavico e il suo verso di scorrimento, nonché stimando l’età delle zone dove sta formandosi una nuova crosta solida che va a ricoprire quella prodotta da precedenti attività effusive”. Secondo Adriano Fontana, “lo studio oggi pubblicato mostra che LBT può essere considerato il primo vero telescopio gigante oggi operativo. Infatti abbiamo dimostrato di poter utilizzare la modalità interferometrica del telescopio per produrre delle immagini con elemento di risoluzione dato dalla separazione di 23 metri dei due specchi primari. In pratica abbiamo utilizzato un telescopio da 23 mt. di diametro, un bel primato visto e considerato che la prossima generazione di telescopi giganti in fase di progettazione va dai 24.5 mt. di GMT ai 39 mt. di E-ELT e che per vederli in funzione dovremo aspettare ancora diversi anni”. Chi pensa che al di fuori del Sistema Solare non possa esserci la vita, oggi è in forte minoranza nella comunità scientifica mondiale. Anche se non ci sono prove certe dirette dell’esistenza di un esopianeta davvero vivibile con le identiche condizioni atmosferiche della Terra, gli studiosi sono quasi certi che là fuori nell’Universo esistono molti più pianeti in cui è possibile trovare acqua allo stato liquido rispetto a quanto pensato finora. Ad affermarlo non sono gli autori di Star Trek, Stargate e Star Wars, ma un gruppo di ricercatori dell’Università di Toronto (Canada) che ha pubblicato uno studio su Science Express dal titolo “Asynchronous rotation of Earth-mass planets in the habitable zone of lower-mass stars”, sui pianeti su cui potenzialmente “oceani potrebbero avere un clima molto simile alla Terra”, rivela Jeremy Leconte dell’Istituto Canadese di Astrofisica Teorica (CITA), autore principale della ricerca.
Quello che hanno sempre pensato gli scienziati è che i pianeti extrasolari si comportino in modo contrario a quello della Terra, cioè mostrino sempre una sola faccia alla loro stella madre essendo così praticamente invivibili. Se fosse davvero così, allora questi pianeti ruoterebbero in maniera sincrona con la stella, un emisfero sarebbe in perpetua oscurità e le temperature sarebbero decisamente fredde. Leconte e colleghi suggeriscono, però, che durante il moto di rivoluzione attorno alle loro stelle, questi pianeti ruotino talmente velocemente da presentare comunque un ciclo di giorno e notte simile a quello del nostro pianeta, che da noi oggi dura circa 24 ore. Se la teoria del gruppo di ricerca fosse corretta allora non ci sarebbe un lato perennemente freddo e al buio sui pianeti extrasolari, fenomeno che porta l’acqua a rimanere intrappolata in una lastra di ghiaccio gigantesco. “La possibilità che questi pianeti ospitino la vita rimane comunque una questione aperta”, ammette Leconte. “In realtà – osserva Isabella Pagano dell’Osservatorio Astrofisico Inaf di Catania, esperta nella ricerca di esopianeti – il lavoro riguarda i pianeti nella zona abitabile di stelle di piccola massa. La zona abitabile è tanto più vicina quanto minore è la luminosità intrinseca della stella. Gli astri di piccola massa, più freddi e piccoli rispetto al Sole, hanno quindi la zona abitabile abbastanza vicina, e i pianeti che vi si trovano riescono a sincronizzare anche in breve tempo la propria velocità di rivoluzione con quella di rotazione. In condizioni di sincronizzazione la differenza di irradiazione tra l’emisfero rivolto sempre verso la stella e l’altro, è troppo grande e quindi questi pianeti sono pessimi candidati per l’abitabilità”. La ricerca è stata realizzata grazie a un modello climatico tridimensionale che gli studiosi hanno sviluppato per prevedere “l’effetto dell’atmosfera di un determinato pianeta sulla velocità della sua rotazione, che si traduce in cambiamenti clima – spiega Leconte – infatti l’atmosfera è un fattore chiave che colpisce la rotazione di un pianeta, il cui impatto può essere sufficiente per superare la rotazione sincrona e permette a un pianeta di avere un ciclo giorno-notte”. Gli astronomi credono e sperano che alcuni esopianeti abbiano un’atmosfera simile a quella della Terra, dopotutto anche sottile. Sul nostro pianeta la maggior parte della luce solare arriva sulla superficie e il calore viene enfatizzato perché rimane intrappolato, mitizzando le temperature su tutto il pianeta, grazie anche all’effetto dei venti. L’impatto è talmente significativo che supera l’effetto di attrito mareale esercitato da una stella su qualsiasi oggetto in orbita intorno ad essa, proprio come, invece, la Terra fa sulla Luna. Leconte sottolinea, infatti, che “la Luna ci mostra sempre lo stesso lato perché l’attrito provocato dalle maree alterano la sua rotazione. La Luna è in rotazione sincrona con la Terra”. Ecco perché si parla spesso di un lato oscuro della Luna che non riusciamo mai a vedere. Dallo studio canadese si evince che un gran numero di esopianeti simili alla Terra, già noti alla comunità scientifica, potrebbe non avere un moto di rotazione sincrona, come inizialmente creduto. Ma non si canti vittoria, perché è vero che potrebbero avere un ciclo di giorno e notte, ma è anche possibile che questi giorni durino l’equivalente terrestre di settimane o mesi. Il Gemini Planet Imager (GPI) è uno strumento ottico ad alto contrasto montato nel Novembre del 2013 sul Gemini South Telescope di 8 metri in Cile. Le ottiche sono state ideate per aiutare gli astronomi a osservare direttamente e caratterizzare gli ambienti vicini a stelle luminose, cercando la luce di esolune come Pandora nel colossal Avatar negli esopianeti simili a Giove e studiare il materiale protostellare con una sensibilità decisamente maggiore rispetto ad altri sistemi di “imaging” degli esopianeti esistenti. Il GPI, nel corso di un anno di attività, ha prodotto straordinarie immagini e i risultati sono stati presentati nel corso del 225.mo Meeting dell’American Astronomical Society (AAS) a Seattle (Oregon, Usa). Marshall Perrin, uno dei “team leader” che lavora allo strumento, ricercatore allo Space Telescope Science Institute, rivela alcune delle immagini e degli spettri dettagliati del sistema planetario multiplo HR8799 con particolari mai visti prima sull’anello di polvere che avvolge la giovane stella binaria HR4796A nella costellazione del Centauro a 237 anni luce dalla Terra.
La stella e il suo disco, visti da alcune angolazioni, sembrano quasi un occhio e per questo tra gli appassionati l’oggetto è conosciuto come l’Occhio di Sauron. “Le funzionalità avanzate di imaging del GPI hanno portato a dati unici – afferma Perrin – questo strumento ci sta aiutando a capire meglio cosa accade intorno a queste stelle”. Il gruppo di ricerca studia la conformazione del disco attorno alla stella HR4796A. Il sensore GPI non solo cattura dettagli precisi e inediti, ma misura la polarizzazione della luce. Nello specifico, le analisi condotte con il Gemini Planet Imager in Cile sul disco circumstellare della giovane stella mostrano che è parzialmente opaco, il che sta a significare che è molto più denso del previsto e il materiale polveroso è molto più compresso rispetto alla polvere trovata alle estremità del Sistema Solare. Il diametro del disco, che possiamo immaginare come un anello spesso di polvere e gas, la materia prima per la formazione di stelle e pianeti, è il doppio del diametro dell’orbita planetaria all’interno del nostro Sistema Solare e la stella in questione ha una massa che supera del doppio quella del nostro Sole. Patrick Ingraham del gruppo di ricerca per la Stanford University, ha condotto uno studio sulla stella bianca HR8799 nella costellazione di Pegaso, a 129 anni luce dalla Terra, riferendo che le forme degli spettri di due dei quattro pianeti massicci analizzati differiscono più profondamente, nei colori, di quanto previsto, indicando differenze significative tra questi pianeti. “I modelli atmosferici attuali dei pianeti extrasolari non possono spiegare pienamente le sottili differenze di colore che GPI ha rivelato – rivela lo scienziato – ne deduciamo che diverse possano essere la copertura delle nuvole o la loro composizione. Il fatto che GPI sia stato in grado di estrarre nuove conoscenze in un lasso di tempo così breve dalla sua messa in funzione, anche in condizioni sfavorevoli, è una vera e propria testimonianza di quanto rivoluzionario sarà questo strumento nel campo dei pianeti extrasolari”. Durante i primi mesi di lavoro, il sensore GPI ha osservato anche asteroidi, stelle sul punto di morte e numerosi altri esopianeti. Beta Pictoris b, un pianeta già osservato dal Very Large Telescope, che si trova a 63 anni luce dal nostro Sistema Solare, orbita attorno a una stella simile al nostro Sole, ma molto più giovane, circa 12 milioni di anni. Il Sole ha quasi 4,6 miliardi di anni. Ora, usando questo strumento di nuova generazione, i ricercatori hanno rintracciato l’orbita del pianeta che è almeno quattro volte le dimensioni di Giove. “Anche se non è semplice, ora il GPI opera quasi automaticamente”, rivela Fredrik Rantakyro. Lo strumento è disponibile per gli astronomi e le loro osservazioni sono già in programma. Ciò che si spera riescano a fare gli esperti in futuro, è di scoprire un nuovo pianeta, obiettivo ancora non raggiunto con il Gemini Planet Imager, perché il gruppo di ricerca ha preferito, almeno nel primo anno di test, concentrarsi su oggetti e dischi già conosciuti dalla comunità scientifica. Ovviamente, adesso il GPI è pienamente funzionante e si aggiunge agli altri numerosi strumenti che danno la caccia a esopianeti sconosciuti e lontani. Lo strumento è inoltre coinvolto nella Gemini Planet Imager Exoplanet Survey (GPIES) che nei prossimi anni osserverà 600 stelle. Il GPI studia i pianeti attraverso la luce infrarossa che emettono e quindi il team di GPIES ha riunito un elenco delle stelle più giovani da poter analizzare. Finora ha osservato 50 stelle, ma l’analisi dei dati è ancora in corso. “Con il GPI possiamo dire quasi immediatamente se un oggetto non è un pianeta – osserva Bruce Macintosh, “principal investigator” per lo strumento – piuttosto che stare col fiato sospeso per mesi, e possiamo quindi superare la nostra delusione passando subito a un altro obiettivo. Ma ora è il momento di trovare nuovi pianeti!”. Una nuova superterra è quella trovata da un team internazionale di astronomi di Stati Uniti d’America, Italia, Svizzera, Gran Bretagna, Canada e Portogallo, diretto da Andrew Vanderburg dell’Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA) usando i dati raccolti durante le osservazioni di test della missione K2, durate 9 giorni nel Febbraio 2014.
Per quattro anni il Telescopio Spaziale Kepler ha osservato in modo continuo la stessa regione di cielo, cercando fluttuazioni piccolissime della luminosità di oltre 150mila stelle, dovute al transito di pianeti davanti ad esse. Le osservazioni di Kepler hanno rivoluzionato la ricerca degli esopianeti, con la scoperta fino ad oggi di almeno 1900 pianeti confermati. Nel Maggio 2013, mentre una buona parte dei dati Kepler doveva ancora essere analizzata, il secondo dei quattro giroscopi si è danneggiato. L’elevatissima accuratezza nella misura della luminosità stellare caratteristica di Kepler è ottenuta con un sistema di puntamento molto preciso che richiede l’utilizzo di almeno tre giroscopi. Così quando si ruppe il secondo, mettendo fine alla missione originaria di Kepler, in molti pensarono che sarebbe stata la fine dell’utilizzo del satellite. Niente più lontano dalla realtà! I ricercatori e ingegneri non hanno voluto rinunciare a un utilizzo alternativo del Telescopio Spaziale Keplero. Così progettarono una missione alternativa, in cui il satellite avrebbe osservato parecchie regioni lungo l’eclittica (orbita del Sole) con l’aiuto della pressione della radiazione solare per controllare il puntamento insieme ai giroscopi sopravvissuti. La nuova missione, chiamata K2, prosegue le ricerche di Kepler dei pianeti extrasolari, e osserva anche ammassi stellari, galassie attive e supernovae. Kepler ha mantenuto le promesse! La conferma viene dalla scoperta e caratterizzazione del primo pianeta dalla “seconda vita” di Kepler. Dato che le capacità di puntamento di Kepler sono ridotte, per estrarre dati accurati, è necessaria un’analisi molto sofisticata. Vanderburg e colleghi hanno sviluppato un software specializzato per correggere i movimenti del satellite, riuscendo ad ottenere una precisione che è circa la metà di quella della missione originaria: così analizzando i dati si sono così accorti che Kepler aveva osservato un transito planetario. Altri ne sono stati poi rivelati in modo meno evidente con il satellite MOST (Microvariability and Oscillations of STars). “Avevamo bisogno di una conferma autorevole di questo risultato, come quella che solo HARPS-N sa offrire – rivela Emilio Molinari – le misure estremamente precise di HARPS-N confermano che si tratta proprio di un pianeta e ci danno anche preziose informazioni sulle sue proprietà come massa e densità”. Il team ha determinato le velocità radiali del sistema planetario HIP116454 dalle osservazioni di HARPS-N ottenute fra Luglio e Settembre 2014. Il nuovo pianeta HIP116454b, ha un diametro di 32200 km, due volte e mezzo la dimensione della Terra, e HARPS-N ha mostrato che la sua massa è circa dodici volte quella della Terra. Questo rende HIP116454b una super-Terra, una classe di pianeti che non esiste nel nostro Sistema Solare. La densità media suggerisce che il pianeta sia un mondo oceanico, costituito per tre quarti di acqua e un quarto di roccia, ovvero un mini-Nettuno con un’atmosfera gassosa estesa. Gli astronomi stimano una temperatura del pianeta vicina ai 400 gradi centigradi. HIP116454b ha un periodo orbitale di 9.1 giorni e quindi orbita a circa 13.5 milioni di Km dalla sua stella, 11 volte più vicino della distanza Terra-Sole. La stella centrale, HIP116454, è arancione, un po’ più piccola del Sole, nella costellazione dei Pesci a circa 180 anni luce dalla Terra. “HARPS-N ha già scoperto e caratterizzato molti pianeti extrasolari – afferma Giampaolo Piotto, astronomo dell’Università di Padova e coautore del lavoro per la rivista “The Astrophysical Journal” – ma siamo particolarmente felici per HIP116454b perché questo è il primo pianeta confermato della nuova vita di Kepler”. Questi mondi alieni sono incredibilmente diversi, alcuni sono giganti gassosi, come Giove, altri sono di tipo roccioso, come la Terra. Gli esopianeti orbitano attorno alla propria stella a distanze diverse, da meno di un milione di chilometri fino a quasi 100 miliardi di chilometri. I corpi celesti che sono molto vicini alle loro stelle sono soggetti a condizioni estreme: basti pensare alle elevate temperature che spesso superano i 1000 gradi Celsius e alla deformazione causata dalle forze di marea risultanti dal campo gravitazionale stellare. Quest’ultimo effetto è naturalmente visibile nel caso di pianeti dotati di un’atmosfera, come i gioviani caldi, e risulta più difficile da osservare nel caso dei corpi celesti simili al nostro pianeta.
Prabal Saxena, ricercatore della George Mason University, e il suo gruppo hanno sviluppato una serie di modelli per i pianeti che si trovano vicini ad una nana rossa, molto più debole del Sole, la più comune tra le stelle presenti nella Via Lattea. In tal caso il moto di rotazione del pianeta è bloccato: il corpo celeste mostra sempre la stessa faccia alla sua stella mentre orbita, come nel caso della Luna con la Terra. In queste condizioni, gli astronomi prevedono che il grado di deformazione sia misurabile quando il pianeta transita davanti alla sua stella. Se gli scienziati saranno in grado di trovare questi casi estremi, allora si potranno ricavare preziosi indizi sulle proprietà fisiche globali degli esopianeti terrestri. “Immaginate di prendere un pianeta come la Terra o Marte e di porlo vicino ad una nana rossa e poi di deformarlo – osserva Saxena – se analizziamo solamente la forma che assume il corpo celeste, essa ci dirà molto sulla sua struttura interna, altrimenti impossibile da studiare, e come l’oggetto stesso cambia nel tempo”. I deboli segnali associati a quei mondi alieni deformati dalla forza di gravità della propria stella, possono essere catturati dagli attuali telescopi spaziali e, certamente, da strumenti ancora più potenti, come il Telescopio Spaziale James Webb e l’E-ELT che entreranno in funzione nei prossimi anni. È il nostro involucro naturale che ha permesso la formazione e l’evoluzione della vita e che continua a proteggerci da molti rischi provenienti dallo spazio. La nostra atmosfera è una fantastica invenzione da cui dipendiamo indissolubilmente. Anche il suo passato, come quello del nostro pianeta, è stato alquanto turbolento: i ricercatori sono convinti che per ben due volte nella storia della Terra, l’atmosfera sia stata completamente rimossa e ricostituita. Le cause di questi profondi sconvolgimenti sono stati a lungo dibattuti. Tra gli indiziati principali ci sono gli impatti primordiali di corpi celesti, asteroidi e comete che avrebbero destabilizzato a tal punto la giovane Terra da strapparle via i suoi strati gassosi primordiali. Di questo scenario sono convinti assertori anche Hilke Schlichting, Re’em Sari e Almog Yalinewich, scienziati rispettivamente del Massachusetts Institute of Technology (Usa), Hebrew University (Israele) e California Institute of Technology (Usa), che hanno pubblicato sulla rivista Icarus un corposo studio sui processi in grado di portare alla perdita dell’atmosfera primordiale terrestre. I risultati mettono in evidenza un punto essenziale: confermando la responsabilità degli impatti con altri corpi celesti, i ricercatori propendono per uno scenario dove decine di migliaia di scontri con piccoli asteroidi abbiano lentamente ma inesorabilmente espulso via dal pianeta Terra piccole porzioni di atmosfera, fino alla sua completa cancellazione. Il gruppo ha esaminato quale frazione di atmosfera sarebbe stata erosa sia da un singolo scontro con un corpo delle dimensioni di Marte sia da impattori del diametro di 25 chilometri o meno. Le analisi delle simulazioni indicano che, nel primo caso, si sarebbe generata un’onda d’urto sulla Terra in grado di provocare, tra i vari effetti, la perdita di una frazione significativa, se non tutta, della sua atmosfera. Ma l’urto sarebbe stato così violento da provocare la completa fusione di tutto il pianeta Terra, nucleo incluso, come su Krypton, e avrebbe causato una perdita di elementi volatili non compatibile con le abbondanze di 3He (Elio tre) misurate nelle rocce del mantello terrestre. Gli autori sono quindi poco favorevoli a considerare questa possibilità.
La seconda ipotesi è invece quella caldeggiata: impatti meno invasivi con corpi celesti più piccoli avrebbero comunque avuto l’energia necessaria per strappare via piccole porzioni di atmosfera. Per completare l’opera, ovvero rimuovere completamente tutto il guscio di gas terrestre, ci sarebbero voluti decine di migliaia di questi eventi. Uno scenario assolutamente compatibile con ciò che sarebbe avvenuto circa 4,5 miliardi di anni fa, in un’epoca in cui nel Sistema Solare scorrazzavano centinaia di migliaia di frammenti rocciosi e gli scontri tra i vari corpi celesti in formazione erano frequentissimi. Ammesso dunque che così siano andate le cose, resta da acclarare come abbia fatto allora a ricostituirsi l’atmosfera terrestre. Il team ha una risposta anche a questo quesito, legata agli impatti stessi impatti in piccolo taglia che avrebbero fatto piazza pulita di quella primordiale. “Quando si verifica un impatto – spiega Schlichting – l’energia rilasciata dissolve in parte o completamente il proiettile cosmico, così gli elementi volatili contenuti in esso possono disperdersi nell’atmosfera. In questo modo questi eventi possono sì svuotare l’atmosfera, ma anche reintegrarne una parte”. Non solo. “Quello dell’evoluzione dell’atmosfera primordiale della Terra è un problema fondamentale dal punto di vista dell’astrobiologia, dato che la Terra è il metro su cui misuriamo i pianeti extrasolari per comprendere se siano abitabili o meno – rimarca Diego Turrini, planetologo dell’INAF-IAPS di Roma – come spiegano gli autori dello studio, a oggi sappiamo che la Terra dovrebbe aver perso la sua atmosfera almeno due volte nel corso del suo primo miliardo di anni di vita. L’esatta evoluzione atmosferica del nostro pianeta, però, è ancora avvolta nel mistero. Uno degli aspetti più affascinanti di questo lavoro è il fatto che l’erosione e il riformarsi dell’atmosfera primordiale terrestre siano legati a processi comuni a tutti i modelli e scenari di formazione planetaria, sia che riguardino il Sistema solare sia gli esopianeti. I risultati di questo studio, quindi, non ci aiutano solo a capire meglio quando e come la nostra Terra sia diventata abitabile, ma gettano anche nuova luce su quanto diffuse possano essere le atmosfere abitabili nella nostra Galassia”. Naturalmente la caccia grossa ai pianeti extrasolari si fa anche da Terra. Se infatti finora la ricerca di esopianeti avveniva prevalentemente con telescopi spaziali come Kepler e da Terra grazie allo spettrografo HARPS, ora un gruppo di ricercatori ha dimostrato che, nonostante le turbolenze prodotte dall’atmosfera terrestre, si possono scoprire pianeti extrasolari anche molto piccoli usando la tecnica del transito. Alcuni ricercatori infatti hanno eseguito le osservazioni con lo strumento Nordic Optical Telescope, un modesto telescopio di 2,5 metri situato sull’isola di La Palma in Spagna, mentre le precedenti osservazioni dell’esomondo 55 Cancri-e erano state effettuate con i telescopi spaziali. Durante il suo transito, il pianeta passa davanti la sua stella ospite, 55 Cancri, che si trova a quasi 41 anni luce nella costellazione del Cancro, visibile ad occhio nudo, bloccando una minima frazione della luce stellare pari a 1/2000, equivalente allo 0,05 percento, per quasi due ore. “Le nostre osservazioni dimostrano che possiamo rivelare i transiti di pianeti molto piccoli utilizzando i telescopi terrestri – rivela Ernst de Mooij della Queen’s University di Belfast in Inghilterra, autore principale dello studio – si tratta di un risultato particolarmente importante poiché le prossime missioni spaziali, quali TESS e PLATO, dovrebbero essere in grado di identificare numerosi pianeti di tipo terrestre attorno alle rispettive stelle ospiti”. TESS è una missione della Nasa il cui lancio è previsto nel 2017. PLATO è una missione dell’Esa il cui lancio è in programma per il 2024. Lo scopo di entrambe le spedizioni scientifiche spaziali sarà la ricerca di pianeti terrestri alieni con il metodo del transito. “È davvero significativo ciò che possiamo fare spingendo al limite gli strumenti che abbiamo a disposizione a dispetto delle difficoltà che pone la turbolenza atmosferica dovuta al nostro pianeta – confessa il Professor Ray Jayawardhana della York University di Toronto, co-autore della ricerca – le osservazioni come queste stanno aprendo una nuova strada man mano che tentiamo di trovare segni di vita su altri mondi alieni. L’identificazione di una pianeta su distanze dell’ordine di decine di anni luce non è immediato ma può essere fatto con la giusta tecnica e con un po’ di ingegno”. Il pianeta 55 Cancri-e è 2-3 volte più grande e circa 8 volte più massiccio della Terra, simile a Nettuno, ha un periodo orbitale di 18 ore ed è il più interno dei cinque pianeti che formano il sistema planetario alieno. A causa della sua vicinanza alla stella, sul pianeta fa molto caldo al punto che la temperatura superficiale della parte esposta alla stella supera i 1700 gradi Celsius, cioè tale da fondere il metallo.
Qui le condizioni estreme non sono adatte per la vita su base carbonio come la intendiamo oggi sulla Terra. Identificato inizialmente nel 2004 attraverso le variazioni della velocità radiale della sua stella, l’esopianeta è stato poi confermato osservando il suo transito davanti alla stella madre con i telescopi MOST e Spitzer. Finora, solo il transito di un’altra superterra, GJ 1214b, che orbita attorno ad una nana rossa, era stato rivelato con telescopi situati a terra. Nonostante la turbolenza atmosferica del nostro pianeta renda estremamente difficili tali osservazioni, il successo ottenuto dai ricercatori nel caso di 55 Cancri-e, apre nuove prospettive verso la ricerca di altri pianeti alieni di tipo terrestre per le future osservazioni del cielo. Il passo successivo sarà quello di analizzare l’atmosfera dell’esopianeta per vedere se sono presenti tracce riconducibili alla presenza di molecole d’acqua. E se tutto ciò è già possibile con telescopi di piccole dimensioni, è lecito immaginare cosa sarà possibile fare con l’E-ELT dell’Eso, il megatelescopio ottico europeo del diametro di 39 metri, in costruzione in Cile. Un team di astronomi delle università delle Hawaii, della California e del Tennessee ha scoperto un sistema planetario in orbita intorno ad una stella che si trova a soli 54 anni luce dalla Terra, utilizzando i dati raccolti dal telescopio Automated Planet Finder (APF) del Lick Observatory, il Keck Observatory e l’Automatic Photometric Telescope (APT) del Fairborn Observatory (Usa).
Tutti e tre i pianeti osservati orbitano attorno alla loro stella ad una distanza inferiore a quella di Mercurio rispetto al Sole, completando le loro orbite in 5, 15 e 24 giorni terrestri. Il team ha stanato i nuovi esopianeti rilevando le oscillazioni della stella ospite, HD7924, dovute alle orbite e agli effetti gravitazionali planetari sull’astro. I dati raccolti dall’APF e dal Keck Observatory hanno permesso di tracciare gli esomondi con la tecnica Doppler, grazie alla quale sono già stati scoperti con successo centinaia di pianeti più grandi, per lo più intorno a stelle vicine. L’APT ha ottenuto misure essenziali della luminosità di HD7924. La nuova struttura dell’APF offre la possibilità di velocizzare la ricerca di esopianeti: il telescopio robotico infatti si dedica alla ricerca di pianeti extrasolari ogni notte serena ed è in grado di misurare con estrema precisione le velocità radiali delle stelle. Realizzare un Osservatorio totalmente robotizzato e gestito da computer, senza la supervisione umana, ha richiesto anni di sforzi da parte dello staff dell’Università della California. “Inizialmente abbiamo utilizzato l’APF come un telescopio normale, restando svegli tutta la notte e studiando ogni singola stella – rivela B.J. Fulton dell’Università delle Hawaii – ma l’idea di lasciare che un computer si prendesse carico del turno di notte diventava sempre più attraente, dopo mesi di veglie notturne, così abbiamo scritto un software per essere sostituiti da un robot”. Nel 2009 l’Osservatorio Keck ha trovato la prima prova di esopianeti in orbita attorno alla stella HD7924, scoprendo l’esomondo più interno grazie allo strumento HIRES installato sul telescopio da 10 metri Keck I. Questa stessa combinazione è stata utilizzata anche dal gruppo guidato da Andrew Howard dell’Università delle Hawaii e Geoffrey Marcy dell’Università della California, per trovare altri pianeti di tipo terrestre in orbita attorno a stelle vicine. Ci sono voluti cinque anni di ulteriori osservazioni al Keck Observatory e la campagna di un anno e mezzo al telescopio APF, per trovare gli altri due pianeti in orbita su HD7924. Il Telescopio Spaziale Keplero ha scoperto migliaia di pianeti extrasolari, dimostrando che sono estremamente comuni nella nostra Galassia. Tuttavia, quasi tutti questi pianeti sono molto lontani dal nostro Sistema Solare, praticamente irraggiungibili con le nostre primitive tecnologie chimiche di volo spaziale. Per le stelle più vicine alla Terra, entro i 100 anni luce dal Sole, nella maggior parte dei casi non è stata ancora condotta una ricerca accurata della presenza di superterre che Kepler ha invece trovato in grande abbondanza a migliaia di anni luce di distanza. Questa ipermetropia cognitiva tecnologica finora è stata francamente imbarazzante! La scoperta degli Americani mostra il tipo di sistemi esoplanetari che gli astronomi si aspettano di trovare nei prossimi anni per stelle nei nostri dintorni. “I tre pianeti sono diversi da qualsiasi cosa presente nel nostro Sistema Solare – osserva Lauren Weiss dell’Università della California – con masse 7-8 volte quella della Terra e orbite molto vicine alla loro stella ospite”. Il livello di automazione acquisito “cambierà le regole del gioco per l’Astronomia – dichiara Howard – è un po’ come possedere un’auto senza conducente che va a fare shopping di pianeti”. Le osservazioni raccolte da APF, APT e Keck Observatory hanno permesso di verificare la presenza dei tre pianeti, escludendo altre spiegazioni. “Le macchie stellari, come le macchie solari che si osservano sul Sole – spiega Evan Sinukoff dell’Università delle Hawaii, co-autore della scoperta – possono imitare il comportamento di piccoli pianeti in orbita attorno alla stella. Osservazioni ripetute nel corso di anni ci hanno permesso di individuare i segnali dovuti a macchie stellari e di distinguerli dai segnali dovuti alla presenza di questi nuovi pianeti”. Le osservazioni robotiche di HD7924 sono solo l’inizio di una ricerca sistematica di superterre in orbita attorno a stelle vicine. Fulton guiderà lo studio con l’APF per la sua tesi di dottorato. “Quando l’indagine sarà completa – spiega il ricercatore – avremo un censimento di piccoli pianeti orbitanti attorno a stelle simili al Sole entro una distanza di circa 100 anni luce dalla Terra”.
L’automazione dei telescopi è relativamente nuova per l’Astronomia e gli astronomi dell’Università delle Hawaii stanno costruendo due impianti all’avanguardia. Christoph Baranec ha costruito l’Osservatorio Robo-AO che raccoglie immagini ad alta risoluzione utilizzando un laser per rimuovere la sfocatura dovuta ai gas dell’atmosfera terrestre, e John Tonry sta sviluppando ATLAS, un Osservatorio robotico in grado di dare la caccia agli asteroidi potenzialmente pericolosi per la Terra. Il colossal Intestellar di Nolan si basa in larga parte sulle teorie scientifiche e i lavori di Kip Thorne, fisico teorico statunitense, consulente della produzione, specializzato in Fisica della Gravitazione e Astrofisica. È uno dei maggiori esperti di Relatività Generale. Thorne è conosciuto soprattutto per le sue teorie sulla possibilità di viaggi nel tempo tramite cunicoli spaziotemporali. L’idea di andare a cercare risorse su altri pianeti non è nuova per la cinematografia e neanche per la Scienza, seppure con programmi che non prevedono per il momento di sfruttare i buchi neri per “accorciare” i voli spaziali sfruttando le reali proprietà elastiche dello spaziotempo di Einstein. La ricerca sui pianeti extrasolari che viene fatta attraverso lo spettrografo HARPS dell’Eso e il telescopio orbitante Kepler hanno già portato alla scoperta di un gran numero di essi. Attualmente la Nasa ha in corso varie mission sulla possibilità di colonizzare altri pianeti all’interno del nostro Sistema Solare, Marte e Venere in primis terraformandoli per far sopravvivere i coloni. Tra queste la Mars Plant Experiment che ha come traguardo il 2021 e per la quale sono in corso esperimenti con l’impianto di piccole serre, e la missione Veg-01 che esplora la possibilità di far crescere piante sulla Stazione Spaziale Internazionale. I Russi hanno programmi ancora più ambiziosi che i media occidentali ignorano, come la fondazione di una colonia umana permanente sulla Luna entro pochissimi mesi. Per poi conquistare il Sistema Solare e ammirare direttamente dallo spazio il paesaggio sensazionale nella costellazione meridionale dell’Altare che racchiude come uno scrigno molti tesori celesti. Ammassi stellari, nebulose a emissione e regioni di formazione stellare attiva sono solo alcuni dei gioielli osservati in questa zona che si trova a circa 4000 anni luce dalla Terra. La bella immagine ripresa dal VST, il telescopio per survey del VLT, all’Osservatorio dell’Eso al Paranal in Cile, è la veduta finora più dettagliata di questa parte di cielo. Al centro si osserva l’ammasso stellare aperto NGC 6193 che contiene una trentina di stelle brillanti e forma il cuore dell’associazione OB1 dell’Altare. Le due stelle più brillanti sono giganti molto calde. Insieme costituiscono la fonte principale d’illuminazione della vicina Nebulosa a emissione Rim, la NGC 6188, visibile a destra dell’ammasso. Un’associazione stellare è un grande gruppo di stelle legate debolmente che non si sono ancora del tutto allontanate dal luogo di formazione iniziale. Le associazioni di tipo OB sono composte per la maggior parte da astri molto giovani bianco-blu, circa 100mila volte più luminose e 10-50 volte più massicce del Sole. La Nebulosa Rim è il muro di nubi scure e luminose che marca il confine tra una regione di formazione stellare attiva all’interno della nube molecolare, nota come RCW108, e il resto dell’associazione. L’area intorno a RCW108 è composta per la maggior parte da idrogeno, l’ingrediente primario della formazione stellare. Queste aree sono conosciute anche come regioni H II. La radiazione ultravioletta e i venti stellari intensi dalle stelle di NGC 6193 sembrano stimolare una nuova generazione di formazione stellare nelle nubi circostanti di gas e polveri. Quando i frammenti collassano, si scaldano e alla fine formano nuove stelle.
A mano a mano che la nube crea nuove stelle, viene anche erosa dai venti e della radiazione emessa dagli astri delle precedenti generazioni e da violente esplosioni di supernova. In questo modo le regioni H II tendono ad avere una durata di soli pochi milioni di anni. La formazione stellare è un processo energetico molto più efficiente delle pale a vento e dei pannelli fotovoltaici che adornano i padiglioni di Expo2015, ma anche di tutte le centrali nucleari a fissione sulla Terra: circa il 10 percento del materiale disponibile contribuisce al processo, mentre il resto viene soffiato via nello spazio. Alcuni segnali indicano che la Nebulosa Rim potrebbe essere nella fase iniziale di formazione di Pilastri e in futuro potrebbe assomigliare ad altre famose zone di parto stellare, come la Nebulosa Aquila (M16) con i suoi famosi Pilastri della Creazione e della Distruzione, e la Nebulosa Cono parte di NGC 2264. L’immagine più spettacolare e dettagliata di sempre, è stata in realtà creata da più di 500 singole foto prese in quattro diversi filtri di colore con il VST. Il tempo totale di esposizione è stato superiore alle 56 ore. Nuove osservazioni con APEX e altri telescopi rivelano che la stella vista comparire in cielo dagli astronomi europei nel 1670 non era una Nova, ma un tipo più raro e violento di collisione stellare. È stato così spettacolare da essere visibile facilmente a occhio nudo durante il primo scoppio, ma le tracce lasciate erano così deboli che era necessaria un’analisi accurata con telescopi nella banda submillimetrica per poter risolvere l’enigma, svelato finalmente più di 340 anni dopo. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Nature. Alcuni dei più grandi astronomi del XVII Secolo, tra cui Hevelius, padre della cartografia lunare, e Cassini, hanno documentato accuratamente l’apparizione in cielo di una nuova stella nel 1670. Hevelius la descrisse come “nova sub capite Cygni” (una stella nuova sotto il capo del Cigno) ma gli astronomi ora la chiamano Nova Vulpeculae 1670. Si trova entro i confini della moderna costellazione della Volpetta, vicina al Cigno. Viene spesso chiamata Nova Vul 1670 o CK Vulpeculae, designazione da stella variabile. Resoconti storici di novae sono rari e di grande interesse per gli astronomi moderni. Nova Vul 1670 è ritenuta sia la più vecchia sia la più debole delle novae che si ricordino. “Per molti anni si è pensato che questo oggetto fosse una nova – rivela Tomasz Kamiński dell’Eso e del Max Planck Institute di Bonn in Germania – ma più lo si studiava e meno sembrava una nova normale o comunque un qualsiasi tipo di stella esplosa”. Quando è apparsa per la prima volta, Nova Vul 1670 era facilmente visibile a occhio nudo e ha variato la sua luminosità nel corso di due anni, dopodiché è scomparsa e riapparsa per ben due volte prima di sparire del tutto. Anche se ben documentata, agli astronomi mancavano gli strumenti necessari per svelare il mistero sul comportamento peculiare della presunta nova. Nel corso del XX Secolo, gli astronomi hanno imparato che la maggior parte delle novae possono essere spiegate dal comportamento esplosivo instabile di stelle binarie strette, come insegna negli Anni Sessanta il compianto astronomo italiano Piero Tempesti dall’Osservatorio di Collurania. Ma Nova Vul 1670 non aderiva a questo modello e rimase perciò un enigma. Anche con l’aumentare delle capacità dei telescopi, per molto tempo si è pensato che l’evento non avesse lasciato traccia. Solo intorno al 1980 un gruppo di astronomi osservò una debole nebulosa intorno a ciò che si sospettava fosse rimasto della stella. Anche se queste osservazioni fornirono un collegamento allettante con gli avvistamenti del 1670, non riuscirono a gettare nuova luce sulla vera natura dell’evento comparso nei cieli d’Europa più di tre secoli fa. “Abbiamo studiato l’area a lunghezze d’onda submillimetriche e radio – osserva Tomasz Kamiński – trovando che i dintorni del residuo stellare sono immersi in un gas freddo ricco di molecole, con una composizione chimica molto insolita”. Il lavoro, presentato in un articolo intitolato “Nuclear ashes and outflow in the oldest known eruptive star Nova Vul 1670” di T. Kamiński et al., è stato pubblicato dalla rivista Nature, dall’equipe composta da: Karl M. Menten (MPIfR), Romuald Tylenda (N. Copernicus Astronomical Center, Toruń, Polonia), Marcin Hajduk (N. Copernicus Astronomical Center), Nimesh A. Patel (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Cambridge, Massachusetts, USA) e Alexander Kraus (MPIfR). APEX è una collaborazione tra il Max Planck Institut für Radioastronomie (MPIfR), l’Osservatorio spaziale di Onsala (OSO) e l’Eso. La gestione di APEX a Chajnantor è affidata all’Eso. Oltre ad APEX, il team si è avvalso di SMA (Submillimeter Array) e del radiotelescopio di Effelsberg per scoprire la composizione chimica e misurare il rapporto dei diversi isotopi nel gas, per ottenere un disegno accurato della composizione della zona e una valutazione sulla sua origine. L’equipe ha così scoperto che la massa della materia fredda era troppo grande per essere il prodotto di un’esplosione di stella nova, inoltre il rapporto isotopico misurato intorno alla Nova Vul 1670 era diverso da quello previsto per un simile evento. Se non era una nova, allora cos’era? Una collisione spettacolare tra due stelle, più brillante di una nova ma meno di una supernova, in grado di produrre un oggetto noto come Transiente Rosso. Un evento molto raro in Natura in cui le stelle esplodono a causa del loro scontro reciproco, sparando via nello spazio il materiale dall’interno dell’astro, lasciando alla fine solo un debole residuo gassoso incluso in un ambiente fresco, ricco di molecole e polvere! Questa nuova classe di oggetti, ora ufficialmente riconosciuta grazie all’Eso, di stelle in eruzione, si adatta quasi esattamente al profilo della Nova Vul 1670. Per il co-autore della ricerca Kark Menten, “questo genere di scoperta è il più divertente, qualcosa di completamente inaspettato!”. Le migliori osservazioni di sempre della nube di gas e polvere G2 confermano che ha superato il punto di minor distanza dal buco nero super massiccio al centro della Via Lattea nel Maggio 2014, sopravvivendo alla titanica “fatica di Ercole”. Il nuovo risultato del Very Large Telescope dell’Eso, presentato nell’articolo “Monitoring the Dusty S-Cluster Object (DSO/G2) on its Orbit towards the Galactic Center Black Hole” di M. Valencia-S. et al., su “Astrophysical Journal Letters”, mostra che l’oggetto non sembra essersi notevolmente allungato, conservando la sua integrità. Frutto del lavoro dell’equipe composta da: M. Valencia-S. (Physikalisches Institut der Universität zu Köln, Germania), A. Eckart (Universität zu Köln; Max-Planck-Institut für Radioastronomie, Bonn, Germania [MPIfR]), M. Zajacek (Universität zu Köln; MPIfR; Astronomical Institute of the Academy of Sciences Prague, Repubblica Ceca), F. Peissker (Universität zu Köln), M. Parsa (Universität zu Köln), N. Grosso (Observatoire Astronomique de Strasbourg, Francia), E. Mossoux (Observatoire Astronomique de Strasbourg), D. Porquet (Observatoire Astronomique de Strasbourg), B. Jalali (Universität zu Köln), V. Karas (Astronomical Institute of the Academy of Sciences Prague), S. Yazici (Universität zu Köln), B. Shahzamanian (Universität zu Köln), N. Sabha (Universität zu Köln), R. Saalfeld (Universität zu Köln), S. Smajic (Universität zu Köln), R. Grellmann (Universität zu Köln), L. Moser (Universität zu Köln), M. Horrobin (Universität zu Köln), A. Borkar (Universität zu Köln), M. García-Marín (Universität zu Köln), M. Dovciak (Astronomical Institute of the Academy of Sciences Prague), D. Kunneriath (Astronomical Institute of the Academy of Sciences Prague), G.D. Karssen (Universität zu Köln), M. Bursa (Astronomical Institute of the Academy of Sciences Prague), C. Straubmeier (Universität zu Köln) e H. Bushouse (Space Telescope Science Institute, Baltimore, Maryland, USA). Molto probabilmente è una giovane stella con un nucleo massiccio ancora nel processo di accrescimento. Neppure il Gargantua galattico sembra mostrare segni di famelica attività. Un buco nero supermassiccio, con una massa pari a quattro milioni di Soli, si annida nel cuore della Via Lattea. Intorno ad esso orbita un piccolo gruppo di stelle brillanti, oltre a una misteriosa nube di gas e polvere, nota come G2, studiata da anni nella sua caduta verso il buco nero. Il punto di avvicinamento massimo, noto come Peribothron, dalla parola greca che significa “buco, pozzo”, era previsto nel Maggio del 2014. Le forze mareali, come in Interstellar, anche in questa regione di Gravità molto forte, avrebbero dovuto fare a pezzi la nube e disperderla lungo l’orbita. Una parte dei gas avrebbe dovuto nutrire il buco nero, determinando un improvviso brillamento, come prova del gustoso pranzetto inaspettato per il mostro cosmico che influenza tutta la Galassia, dunque anche la Terra. Per studiare questo evento unico, la zona di centro galattico è stata osservata con attenzione negli ultimi anni da numerosi astronomi con grandi telescopi in tutto il mondo. L’equipe guidata da Andreas Eckart dell’Università di Colonia (Germania) ha osservato la regione con il VLT durante il periodo critico da Febbraio a Settembre 2014, appena prima e appena dopo il Peribothron di Maggio 2014. I dati sono consistenti con le precedenti osservazioni effettuate con il telescopio Keck alle Hawaii. La regione è nascosta da spesse nubi di polvere e servono osservazioni in luce infrarossa. Inoltre, l’evento si verifica molto vicino al buco nero e solo l’ottica adattiva è in grado di ottenere immagini sufficientemente nitide. L’equipe con lo strumento SINFONI del VLT ha controllato il comportamento del buco nero centrale, avvalendosi del sensore NACO in luce polarizzata. Le immagini in luce infrarossa dell’idrogeno incandescente mostrano che la nube era compatta sia prima sia dopo l’incontro ravvicinato mentre orbita intorno al buco nero. Oltre a fornire immagini molto nitide, lo strumento SINFONI divide la luce nei suoi colori componenti infrarossi, permettendo di stimare la velocità della nube polverosa che si muove relativamente alla Terra, allontanandosi prima del punto di massima vicinanza al buco nero, e poi avvicinandosi: è l’effetto Doppler che modifica la lunghezza d’onda della luce osservata. Questi cambi di lunghezza d’onda possono essere misurati con uno spettrografo molto sensibile come lo strumento SINFONI sul VLT, che può essere usato anche per misurare la dispersione delle velocità del materiale che ci si aspetterebbe nel caso in cui la nube si estenda lungo l’orbita in modo significativo, com’era stato ipotizzato in precedenza. Prima del massimo avvicinamento, la nube viaggiava allontanandosi dalla Terra a una velocità di circa 10 milioni di chilometri all’ora; dopo aver girato intorno al buco nero si avvicinava alla Terra a una velocità di circa 12 milioni di chilometri orari. Una fionda gravitazionale di tutto rispetto. Anche se osservazioni precedenti avevano suggerito che l’oggetto G2 si fosse allungato, i nuovi dati non hanno offerto alcuna prova del fatto che la nube si fosse distesa, nè diventando visibilmente più lunga nè mostrando una maggior distribuzione in velocità.
Le misure sulla polarizzazione delle luce proveniente dalla regione del buco nero super massiccio, sono le migliori osservazioni di sempre e rivelano che il comportamento della materia in accrescimento sul buco nero è molto stabile, non modificato dall’arrivo della nube G2. La resilienza della nube di polvere agli effetti mareali dovuti all’estrema Gravità, suggerisce fortemente che la polvere circondi un oggetto denso con un nucleo massiccio, e non sia invece una nube liberamente fluttuante. Ciò è anche confermato dalla mancanza di prove che il materiale stia alimentando il mostro centrale, cosa che porterebbe a un’attività intensa di brillamenti. “Abbiamo esaminato tutti i dati recenti, in particolare il periodo nel 2014 in cui si è verificato l’avvicinamento al buco nero – rivela Andreas Eckart – non possiamo confermare alcun significativo allungamento della sorgente. Di sicuro non si comporta come una nube di polvere senza un nucleo. Pensiamo che sia una giovane stella circondata di polvere”. Sempre all’Eso, per la prima volta, la Materia Oscura potrebbe essere stata osservata in interazione con altra Materia Oscura in modalità diversa dalla gravitazionale, su galassie in collisione. Il Very Large Telescope e l’Hubble Space Telescope avrebbero raccolto i primi interessanti indizi sulla natura di questa misteriosa massiccia componente dell’Universo. Grazie al sensore MUSE installato sul VLT e alle immagini di Hubble, un team di astronomi ha studiato la collisione simultanea di quattro galassie nell’ammasso di galassie Abell 3827, tracciando l’ubicazione della massa all’interno del sistema e confrontando la distribuzione della Materia Oscura con la posizione delle galassie luminose. Un po’ come i coraggiosi astronauti guidati dal capitano Jonathan Archer in “Star Trek Enterprise”, per caratterizzare la Distesa Delfica. Anche se la Materia Oscura apparentemente oggi non si vede, l’equipe ha potuto dedurne la posizione usando la tecnica di Albert Einstein: la lente gravitazionale. La collisione è avvenuta per caso proprio davanti a una sorgente molto più distante e non correlata. La massa della Materia Oscura intorno alle galassie in collisione ha distorto lo spaziotempo, esattamente come previsto da Einstein cento anni fa, deviando il percorso dei raggi di luce provenienti dalla lontana galassia di fondo, e distorcendone l’immagine nelle caratteristiche forme arcuate. La teoria corrente è che tutte le galassie si formino all’interno di grumi di Materia Oscura. Senza l’effetto vincolante della forza di gravità dovuta alla Materia Oscura, galassie come la nostra Via Lattea andrebbero in mille pezzi nella rotazione. Per evitarlo, la Natura ha previsto che l’95 percento della massa-energia dell’Universo (frazione di “materia” letteralmente ignota) debba esistere sotto forma di Materia Oscura, la cui vera natura rimane ancora misteriosa. Gli scienziati, grazie anche al Telescopio Planck dell’Esa, hanno scoperto che il contenuto totale di massa-energia dell’Universo sia diviso in proporzione del 68 percento di Energia Oscura antigravitazionale, 27 percento di Materia Oscura e 5 percento di materia barionica visibile. Nello studio presentato in un articolo intitolato “The behaviour of dark matter associated with 4 bright cluster galaxies located in the 10 kpc core of Abell 3827”, pubblicato sulla rivista “Monthly Notices of the Royal Astronomical Society”, i ricercatori hanno osservato nelle quattro galassie interagenti un grumo di Materia Oscura apparentemente rimasto indietro rispetto alla galassia che circonda. La Materia Oscura è ora a circa 5mila anni luce (50mila milioni di milioni di chilometri) indietro rispetto alla galassia. Qualsiasi sonda umana come la Voyager della Nasa, priva di “propulsori fantasma”, impiegherebbe 90 milioni di anni a coprire tale distanza! L’equipe è composta da: R. Massey (Institute for Computational Cosmology, Durham University, Durham, Regno Unito), L. Williams (School of Physics & Astronomy, University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota, USA), R. Smit (Institute for Computational Cosmology, Regno Unito), M. Swinbank (Institute for Computational Cosmology, Regno Unito), T.D. Kitching (Mullard Space Science Laboratory, University College London, Dorking, Surrey, Regno Unito), D. Harvey (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Observatoire de Sauverny, Versoix, Svizzera), H. Israel (Institute for Computational Cosmology, Regno Unito), M. Jauzac (Institute for Computational Cosmology, Regno Unito; Astrophysics and Cosmology Research Unit, School of Mathematical Sciences, University of KwaZulu-Natal, Durban, Sud Africa), D. Clowe (Department of Physics and Astronomy, Ohio University, Athens, Ohio, USA), A. Edge (Department of Physics, Durham University, Durham, Regno Unito), M. Hilton (Astrophysics and Cosmology Research Unit, Sud Africa), E. Jullo (Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, Université d’Aix-Marseille, Marseille, Francia), A. Leonard (University College London, London, Regno Unito), J. Liesenborgs (Hasselt University, Diepenbeek, Belgio), J. Merten (Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, Pasadena, California, USA; California Institute of Technology, Pasadena, California, USA), I. Mohammed (Physik-Institüt, University of Zürich, Zürich, Svizzero), D. Nagai (Department of Physics, Yale University, New Haven, Connecticut, USA), J. Richard (Observatoire de Lyon, Université Lyon, Saint Genis Laval, Francia), A. Robertson (Institute for Computational Cosmology, Regno Unito), P. Saha (Physik-Institüt, Svizzera), R. Santana (Department of Physics and Astronomy, Ohio University, Athens, Ohio, USA), J. Stott (Department of Physics, Durham, Regno Unito) e E. Tittley (Royal Observatory, Edinburgh, Regno Unito). Un ritardo tra la Materia Oscura e la galassia ad essa associate, è previsto durante la collisione se la Materia Oscura interagisce con se stessa, anche se debolmente, grazie a forze diverse dalla gravità. Simulazioni al computer mostrano che l’attrito aggiuntivo dovuto alla collisione, farebbe rallentare la Materia Oscura.
Che, secondo gli autori della ricerca, “non è mai stata osservata prima d’ora interagire in modo diverso dalla forza di gravità”. Non solo. “Eravamo abituati a pensare che la Materia Oscura stesse lì tranquilla, badando solo a se stessa, fatta eccezione per l’attrazione gravitazionale. Ma – osserva Richard Massey dell’Università di Durham – se la Materia Oscura venisse rallentata durante la collisione, potrebbe essere la prima evidenza di una diversa Fisica nella Zona Oscura, l’Universo nascosto intorno a noi”. Chissà, forse come nella Distesa Delfica con le 78 Sfere iperdimensionali costruite dagli Architetti e i Vortici spaziotemporali di Star Trek Enterprise. I ricercatori fanno notare che servono ulteriori indagini su altri effetti che possano produrre un ritardo. Dovranno essere eseguite osservazioni simili su altre galassie e simulazioni numeriche dello scontro tra galassie dove la signora assoluta resta sempre la gravità. “Sappiamo che la Materia Oscura esiste a causa della sua interazione gravitazionale che aiuta a dare una forma all’Universo – osserva Liliya Williams dell’Università del Minnesota – ma sappiamo poco, in modo addirittura imbarazzante, su cosa sia in realtà la Materia Oscura. Le nostre osservazioni suggeriscono che la Materia Oscura interagisca con forze diverse dalla gravità, dimostrando che possiamo scartare alcune delle teorie fondamentali sulla composizione della Materia Oscura”. Tutte e quattro le galassie potrebbero essere state separate dalla loro Materia Oscura. Ma le misure sono buone per una sola galassia, poichè per caso è ben allineata con l’oggetto di fondo distorto dalla lente gravitazionale. Con le altre tre galassie, le immagini dovute alla lente sono più lontane e perciò i vincoli imposti sulla posizione della Materia Oscura sono troppo poco stringenti per trarre conclusioni significative dal punto di vista statistico. Questi risultati discendono da un altro recente studio di questa stessa equipe che ha osservato 72 scontri tra ammassi di galassie, trovando che la Materia Oscura interagisce molto poco con se stessa. Il nuovo lavoro invece riguarda il moto delle singole galassie, non degli ammassi di galassie. I ricercatori sostengono che lo scontro tra queste galassie potrebbe essere durato più a lungo che la collisione osservata nello studio precedente, permettendo agli effetti di una forza di attrito anche minima di crescere nel tempo e produrre un ritardo misurabile. L’incertezza maggiore sul risultato è la durata della collisione: l’attrito che rallenta la Materia Oscura potrebbe essere dovuto a una forza molto debole che agisce per un miliardo di anni o una forza relativamente più intensa che agisce per “soli” 100 milioni di anni. Messi insieme, questi risultati restringono per la prima volta i possibili comportamenti della Materia Oscura. Secondo Massey “stiamo finalmente costringendo la Materia Oscura all’angolo, spingendo la nostra conoscenza da due direzioni diverse”. Nel frattempo l’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array dell’Eso ha rivelato un campo magnetico molto più potente di tutti quelli finora trovati nel cuore delle galassie, vicino all’Orizzonte degli Eventi di un buco nero super massiccio. La nuova osservazione aiuta gli astronomi a capire la struttura e la formazione dei massicci abitanti del centro delle galassie e i collimati getti gemelli di plasma a velocità relativistica che essi emettono dai poli.
I risultati del lavoro intitolato “A strong magnetic field in the jet base of a supermassive black hole”, sono pubblicati da Science. I buchi neri super massicci, spesso con masse di miliardi di volte quella del Sole, si trovano nel cuore di quasi tutte le 400 miliardi di galassie dell’Universo. Su queste stelle nere, che nascondo la Singolarità mai nuda, può accrescere materia in enormi quantità per mezzo di un disco che le circonda. Mentre la maggior parte della materia cade sul buco nero, parte può sfuggire appena prima della cattura ed essere lanciata nello spazio a velocità prossime a quella della luce, sotto forma di un getto di plasma. Come questo accada non è ancora ben compreso, anche se si pensa che i forti campi magnetici, che agiscono in prossimità dell’Orizzonte degli Eventi, rivestano un ruolo cruciale nel processo, aiutando la materia a sfuggire dalle fauci gravitazionali spalancate sull’oscurità. Finora sono stati indagati solo deboli campi magnetici, lontani fino a diversi anni luce dai buchi neri. Campi magnetici molto più deboli sono stati trovati nelle vicinanze del buco nero supermassiccio, ma relativamente quieto, che si trova al centro della Via Lattea. Osservazioni recenti hanno anche svelato campi magnetici deboli nella galassia attiva NGC 1275, rivelati a lunghezze d’onda millimetriche. Nello studio, invece, gli astronomi della Chalmers University of Technology e dell’Onsala Space Observatory in Svezia hanno usato il super radiotelescopio Alma per rilevare segnali direttamente legati a un forte campo magnetico, molto vicino all’Orizzonte degli Eventi del buco nero super massiccio di una galassia lontana chiamata PKS 1830-211, che si trova esattamente nel luogo in cui la materia viene improvvisamente lanciata via dal buco nero sotto forma di getto. Il team ha misurato la forza del campo magnetico studiando il modo in cui la luce è polarizzata mentre si allontana dal buco nero. “La polarizzazione è una proprietà importante della luce e viene usata molto anche nella vita quotidiana – ricorda Ivan Marti-Vidal, primo autore dell’articolo – ad esempio negli occhiali da sole o negli occhialini 3D al cinema. Quando viene prodotta in Natura, la polarizzazione può essere usata per misurare i campi magnetici, poichè la luce cambia la sua polarizzazione quando attraversa un mezzo magnetizzato. In questo caso, la luce che vediamo con Alma ha attraversato un materiale molto vicino al buco nero, una zona piena di plasma altamente magnetizzato”. Come nei reattori di curvatura in Star Trek. L’equipe è composta da: I. Martí-Vidal (Onsala Space Observatory and Department of Earth and Space Sciences, Chalmers University of Technology, Svezia), S. Muller (Onsala Space Observatory and Department of Earth and Space Sciences, Chalmers University of Technology, Svezia), W. Vlemmings (Department of Earth and Space Sciences and Onsala Space Observatory, Chalmers University of Technology, Svezia), C. Horellou (Department of Earth and Space Sciences, Chalmers University of Technology, Svezia) e S. Aalto (Department of Earth and Space Sciences, Chalmers University of Technology, Svezia). Gli astronomi hanno applicato ai dati di Alma una nuova tecnica di analisi da essi stessi sviluppata, trovando che la direzione del piano di polarizzazione della radiazione proveniente dal centro di PKS 1830-211 era ruotata.
I campi magnetici introducono la Rotazione di Faraday che fa ruotare il piano di polarizzazione in modi diversi, a diverse lunghezze d’onda. Il modo in cui questa rotazione dipende dalla lunghezza d’onda, offre informazioni sul campo magnetico nella regione. In effetti si tratta delle lunghezze d’onda più corte di sempre per questo tipo di ricerche, che consente di sondare le regioni molto vicine al buco nero centrale. Le osservazioni con Alma sono state effettuate a una lunghezza d’onda efficace di circa 0,3 millimetri, mentre quelle precedenti a lunghezze d’onda radio molto più lunghe. Solo la luce di lunghezza d’onda millimetrica può sfuggire dalle regioni più vicine al buco nero, mentre le radiazioni di lunghezza d’onda maggiore vengono assorbite. Sull’Orizzonte degli Eventi c’è di tutto, forse tutta l’informazione dell’Universo che si conserva. “Abbiamo trovato un chiaro segnale di rotazione del piano della polarizzazione – rivela Sebastien Muller, co-autore dell’articolo – un segnale centinaia di volte superiore al più alto mai trovato nell’Universo. La nostra scoperta è un balzo gigante in termini di frequenza di osservazione, grazie all’uso di Alma, e in termini di distanza dal buco nero a cui viene sondato il campo magnetico, dell’ordine di alcuni giorni-luce dall’Orizzonte degli Eventi”. Mai così vicini! “Questi risultati e gli studi futuri – conferma Muller – ci aiuteranno a capire cosa stia realmente accadendo nell’immediata vicinanza di un buco nero supermassiccio”. Come in Interstellar. Altri astronomi hanno mostrato per la prima volta come la formazione stellare nelle galassie morte, abbia iniziato a perdere colpi miliardi di anni fa. Il Very Large Telescope dell’Eso e il Telescopio Spaziale Hubble hanno rivelato che tre miliardi di anni dopo il Big Bang, queste galassie costruivano ancora nuove stelle in periferia, ma non più al loro interno. Lo spegnimento della formazione stellare sembra essere iniziato nel nucleo delle galassie e poi essersi diffuso alle zone esterne. Sono i risultati di uno studio presentato nell’articolo “Evidence for mature bulges and an inside-out quenching phase 3 billion years after the Big Bang” di S. Tacchella et al., pubblicato dalla rivista Science. Uno dei più grandi misteri dell’Astrofisica è incentrato su come le galassie ellittiche massicce, quiescenti nell’Universo contemporaneo, abbiano spento il tasso di formazione stellare un tempo forsennato. Queste galassie colossali, spesso chiamate sferoidi a causa della loro forma, impacchettano generalmente le stelle nelle zone centrali con una densità dieci volte superiore a quella della nostra Via Lattea e vantano una massa totale dieci volte superiore. Gli astronomi le chiamano galassie “red and dead”, cioè rosse e morte ovvero spente, poichè presentano una notevole abbondanza di stelle vecchie e rosse (come sarà l’Universo del futuro remoto), una mancanza di stelle giovani e blu e non mostrano evidenza di nuova formazione stellare. L’età stimata delle stelle rosse suggerisce che le galassie ospiti abbiano terminato di produrre nuove stelle circa dieci miliardi di anni fa. Questo spegnimento è iniziato proprio al culmine della formazione stellare nell’Universo, quando molte galassie erano ancora attive nella produzione di stelle a un ritmo venti volte superiore a quello odierno. “Gli sferoidi massicci e spenti contengono circa metà delle stelle che l’Universo ha prodotto in tutta la sua vita – spiega Sandro Tacchella dell’ETH Zurich svizzero, autore principale della ricerca – non possiamo dire di aver capito come si è evoluto l’Universo e come è diventato quale lo vediamo oggi, se non capiamo bene come queste galassie si sono formate”. L’equipe è composta da: Sandro Tacchella (ETH Zurich, Svizzera), Marcella Carollo (ETH Zurich), Alvio Renzini (INAF, Osservatorio Astronomico di Padova, Italia), Natascha Förster Schreiber (Max-Planck-Institut für Extraterrestrische Physik, Garching, Germania), Philipp Lang (Max-Planck-Institut für Extraterrestrische Physik), Stijn Wuyts (Max-Planck-Institut für Extraterrestrische Physik), Giovanni Cresci (INAF, Italia), Avishai Dekel (The Hebrew University, Israele), Reinhard Genzel (Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik e University of California, Berkeley, California, USA), Simon Lilly (ETH Zurich), Chiara Mancini (INAF, ), Sarah Newman (University of California, Berkeley, California, USA), Masato Onodera (ETH Zurich), Alice Shapley (University of California, Los Angeles, USA), Linda Tacconi (Max-Planck-Institut für Extraterrestrische Physik, Garching, Germania), Joanna Woo (ETH Zurich) e Giovanni Zamorani (INAF, Osservatorio Astronomico di Bologna, Italia). Tacchella e colleghi hanno osservato in totale 22 galassie che coprono un ampio intervallo di masse, a partire da un’epoca di circa tre miliardi di anni dopo il Big Bang. L’età dell’Universo è di circa 13,8 miliardi di anni. Quindi le galassie studiate da Tacchella e colleghi sono viste come apparivano circa 10 miliardi di anni fa. Lo strumento SINFONI sul Very Large Telescope ha raccolto la luce da questo campione di galassie, mostrando esattamente il luogo in cui venivano sfornate le nuove stelle.
I ricercatori hanno puntato anche il Telescopio Spaziale Hubble sullo stesso gruppo di galassie, sfruttando la posizione favorevole del satellite nello spazio. La fotocamera WFC3 di Hubble ha scattato immagini nel vicino infrarosso, rivelando la distribuzione spaziale delle stelle più vecchie all’interno delle galassie che stanno attivamente formandone di nuove. “Sorprende che il sistema di ottica adattiva di SINFONI possa cancellare quasi completamente gli effetti atmosferici – osserva Marcella Carollo dell’ETH Zurich, co-autrice dello studio – e raccogliere informazioni sull’ubicazione delle nursery di stelle, con la stessa precisione che Hubble consente di ottenere per la distribuzione della massa stellare”. Secondo i nuovi dati, le galassie più massicce del campione hanno mantenuto una produzione costante di nuove stelle nelle zone periferiche. Nei nuclei e nei rigonfiamenti centrali densamente popolati, invece, la formazione stellare si era già fermata. “Questa dimostrazione del fatto che la formazione stellare si spegne a partire dall’interno nelle galassie massicce – rileva Alvio Renzini dell’Osservatorio Inaf di Padova in Italia – dovrebbe fare luce sui meccanismi coinvolti, che gli astronomi hanno a lungo dibattuto”. Una delle teorie di punta è che il materiale che serve per comporre le stelle viene disperso da torrenti di energia rilasciati dal buco nero super massiccio al centro della galassia mentre divora disordinatamente il materiale circostante. Un’altra ipotesi è che il gas nuovo smetta di fluire verso la galassia, lasciandola a secco di rifornimenti per le nuove stelle e trasformandola in uno sferoide rosso e spento. “Esistono molti suggerimenti teorici su quale meccanismo fisico porti alla morte degli sferoidi massicci – osserva la co-autrice Natascha Förster Schreiber del Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik di Garching in Germania – scoprire che lo spegnimento della formazione stellare è iniziato dal centro e ha percorso la sua strada verso l’esterno è un passo molto importante per comprendere come l’Universo sia diventato quel che appare ora”. Tutto questo mentre un nuovo studio dell’Eso suggerisce che le strutture ormai entrate nell’immaginario mondiale come Pilastri della Creazione, grazie all’HST, dovrebbero in realtà chiamarsi Pilastri della Distruzione! Grazie al sensore MUSE sul Very Large Telescope, alcuni astronomi hanno prodotto la prima visione tridimensionale completa dei famosi Pilastri della Creazione nella Nebulosa Aquila, Messier 16. Il lavoro presentato nell’articolo “The Pillars of Creation revisited with MUSE: gas kinematics and high-mass stellar feedback traced by optical spectroscopy” di A. F. McLeod et al., è stato pubblicato dalla rivista “Monthly Notices of the Royal Astronomical Society”, dall’equipe composta da: A.F. Mc Leod (ESO, Garching, Germania), J.E. Dale (Universitäts-Sternwarte München, München, Germania; Excellence Cluster Universe, Garching bei München, Germania), A. Ginsburg (ESO), B. Ercolano (Universitats-Sternwarte München; Excellence Cluster Universe), M. Gritschneder (Universitats-Sternwarte München), S. Ramsay (ESO) e L. Testi (ESO; INAF/Osservatorio Astrofisico di Arcetri, Firenze, Italia). Le nuove osservazioni dimostrano come i diversi Pilastri di polvere di questa Distesa famosissima siano distribuiti nello spazio e svelano molti dettagli nuovi, tra cui un getto mai visto prima proveniente da una giovane stella. La radiazione intensa e i venti stellari delle stelle brillanti dell’ammasso, hanno scolpito nel tempo i Pilastri della Creazione e dovrebbero farli evaporare completamente nei prossimi tre milioni di anni. L’immagine originale storica dei Pilastri della Creazione fu presa da Hubble esattamente nel 1995 e divenne immediatamente una delle immagini più celebri e suggestive del Telescopio Spaziale consacrandone il successo. Da allora queste nubi fluttuanti che si estendono per alcuni anni luce, hanno stupito scienziati e pubblico. Il Pilastro, a sinistra nell’immagine, considerato un oggetto completo dall’alto in basso, sembra avere una lunghezza di circa quattro anni luce. È il più lungo, circa due volte quello sulla destra. Le strutture sporgenti, insieme all’ammasso vicino NGC 6611, appartengono a una regione di formazione stellare chiamata Nebulosa Aquila, nota anche come M16. La nebulosa e gli oggetti associati si trovano a circa 7mila anni luce dalla Terra nella costellazione del Serpente.
I Pilastri della Creazione sono un classico esempio delle forme a colonna che si sviluppano nelle nubi giganti di gas e polvere, il luogo di nascita delle nuove stelle. Le colonne si formano quando astri massicci di tipo O e B, immensi, appena formati, producono grandi quantità di intensa radiazione ultravioletta e super-venti stellari che soffiano via il materiale meno denso dalle vicinanze. Qui la vita aliena extraterrestre sarebbe virtualmente impossibile se non opportunamente “schermata”! Le zone più dense di gas e polvere, invece, resistono più a lungo all’erosione astrale. Oltre queste sacche di polvere più spesse, il materiale è schermato dal bagliore aspro e intenso delle stelle O e B. Questa “corazza” crea code scure (proboscidi), il corpo tetro di un Pilastro, che puntano in direzione opposta alla stella brillante. Lo strumento MUSE montato sul VLT ha aiutato gli scienziati a chiarire la drammatica evaporazione in corso nei Pilastri della Creazione con un dettaglio senza precedenti, rivelando il loro orientamento. MUSE mostra che la punta della colonna a sinistra è rivolta verso di noi, in cima a un Pilastro che si trova in realtà dietro a NGC 6611, a differenza degli altri. Questa punta riporta i segni dell’impatto della radiazione delle stelle di NGC 6611, e di conseguenza sembra più brillante ai nostri occhi di quelli in basso a sinistra, in mezzo e a destra, le cui punte sono tutte rivolte in direzione opposta rispetto alla nostra direzione di osservazione. Gli astronomi sperano di capire meglio come le stelle giovani di tipo O e B, in NGC 6611, influenzino la formazione della successiva generazione di stelle. Numerosi studi hanno identificato protostelle che si formano in queste nubi: in tal senso sono proprio i Pilastri della Creazione. Lo studio riporta anche nuovi indizi su due stelle in gestazione nel Pilastro a sinistra e in quello in mezzo, così come un getto da una stella giovane che finora era sfuggito all’attenzione. Perchè molte altre stelle si formino negli ambienti come quelli dei Pilastri della Creazione, bisogna vincere la corsa contro il tempo con la radiazione intensa dalle stelle vigorose che continua a limare via i gas e le polveri dei Pilastri. Proprio la misura del tasso di evaporazione dei Pilastri della Creazione, fornisce agli astronomi un arco di tempo utile prima che i Pilastri scompaiano per sempre. Essi infatti perdono circa 70 volte la massa del Sole ogni milione di anni circa. E, basandosi sulla massa attuale di circa 200 volte quella del Sole, i Pilastri della Creazione hanno un’aspettativa di vita non superiore ai tre milioni di anni: un batter d’occhio su scala cosmica, un’eternità per l’Umanità che forse all’epoca avrà già abbandonato la Terra, evolvendo in altre specie senzienti. Un nome più che adatto per queste colonne cosmiche della vita: i Pilastri della Distruzione. La creazione di avamposti umani nel nostro Sistema Solare, grazie alla Santa Russia, potrà effettivamente essere solo una prima fase propedeutica a creare le condizioni per le esplorazioni umane nel resto dell’Universo.
(541)