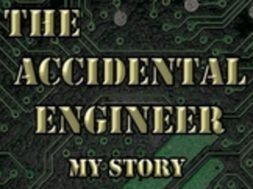(Di Carlo Di Stanislao) I film più belli visti sin’ora a Venezia sono stati “Il salario della paura”, di William Friedkin, andato in Sala Grande dopo la consegna del Leone alla Carriera e “La mani sulla città” di Francesco Rosi, nella versione restaurata dalla Cineteca Nazionale.
Nel primo, anch’esso restaurato per la 70° mostra di Venezia, realizzato nel 1977 e fra i titoli meno noti ed apprezzati del grande regista americano, autore de “Il braccio violento della legge” e “L’esorcista”, che non è (come falsamente si è detto) un remake del film di Clouzot, ma una versione decisamente nuova delòla vicenda di quattro ex galeotti nascosti in un villaggio dell’America Latina , Fiedkin ha espresso appieno la sua idea di cinema e, dalla sue dichiarazioni, si è scoperto che durante le riprese, lui stesso ed altre 50 persone si ammalarono.
Rivedendolo si comprende che il Leone D’Oro è meritatissimo, datoad un regista immenso, coraggioso ed autonomo che ha detto: “Brecht diceva che l’arte non è uno specchio da mostrare alla società, ma un martello per trasformarla. Credo quindi che bisogna dare alle persone un’arte che faccia ragionare. Non ho alcun dubbio, purtroppo sul fatto che il mondo sia giunto alla sua fine. Tutti minacciano tutti, le armi sono nucleari, e basta un solo pazzo per far finire tutto. Chiunque potrebbe oggi mettere fine alla civiltà per come la conosciamo oggi. La missione del cinema è proprio quella di cercare di far ragionare. Non ci sono “superman” o “batman”, ma solo uomini normali, e io credo dobbiamo augurarci che il mondo ritrovi una persona come Gandhi o Martin Luther King, disposto a mettere in gioco la propria vita per la pace. Senza questo ci saranno sempre e solo governi che provocano o minacciano. E io, quando sento che il mio governo che ne minaccia un altro, mi vergogno”.
Tornando al film presentato, girato tra il caldo torrenziale del centroamerica e la rigogliosa giungla,con Friedkin che s’infuria durante le riprese,tra scatti d’ira e licenziamenti coatti di collaboratori e aiuti di regia, con Roy Scheider fu “promosso” regista di seconda unita’; ta sforamenti di budget e uscite in “concomitanza” con cult come “Guerre stellari”, il “Salario” di Friedkin fu un fiasco clamoroso,un flop carrieristico che segnera’ una sorta di “declino” artistico di un regista duro e crudo,diretto e senza sconti,in film dal nichilismo naturale, con quattro personaggi alla deriva,uomini tanto cari ad un cinema dal furore animale e pessimista qual’e quello di Friedkin, in un “paradiso” centroamericano infiltrato dalla puzza di petrolio a stelle e strisce,dove nazionalisti esaltati mettono bombe distruggenti il lavoro dell’oro nero. Friedkin usa i campi lunghi dal principio,entrando a Vera Cruz, Gerusalemme, Parigi e Chicago, presentandoci i misfatti di “eroi” all’incontrario che fuggono dalla legge ritrovandosi prigionieri di se stessi. Poi c’è il centroamerica anticapitalistico e antiamericano almeno sulla facciata,il resto è teatro di un amministrazione fantoccio, corrotta e filoamericana. La rappresentazione di un oasi mascherante vite miserabili è resa da Friedkin un luogo ruspante e pullulante di indios miserabili,aggrappati ai pozzi americani dove i codici vitali sono inversi al comune codice etico e dove l’ignoranza del popolo è il pane quotidiano di cui si nutre uno stato corrotto.I 4 “eroi” ci stanno “bene” in un contesto simile,travestiti da centroamericani dal lavoro fittizio e improvvisato.Per poter fuggire da un simile scatafascio, i 4 accettano una missione suicida: trasportare per conto dell'”amministrazione” del paese un carico di nitroglicerina dallo scoppio facile,tutto questo con 2 camion obsoleti,in mezzo ad una giungla dissestata e impervia,un incarico da kamikaze per sfuggire ad una morte certa correndo contro la vita stessa…..Il salario di Friedkin è cosi’, un’avventura tesa e mutevole,dove i protagonisti sono prigionieri di se stessi e del destino avverso,uomini dipinti da William come chi ha perso tutto e si lancia nella disperazione.Il tocco personale del regista c’è e si vede tutto,in una messa in scena cruda e progressiva,nella violenza fisica e psicologica di figure avverse tra loro,dove la “solidarietà” è solo un viatico per uscire vivi dall’inferno. Opera anticonvenzionale negli schemi,dove la natura circostante diviene il nemico dell’uomo,dove pioggia e querce secolari sono i mostri,dove i predoni sono appostati per farti la pelle.Un film sottovaluto,da recuperare assolutamente per la spirale di un destino crudo e avvolgente.La regia usa infatti la cinepresa a largo raggio,dove la giungla è un inferno amaro e ostico da superare.I protagonisti sono bravi nel compito di disperati alla ricerca di una “liberta’” condizionata,emerge su di tutti il rapinatore Roy Scheider,unico superstite nell’avversita’ di un cataclisma umano e naturale.Il Friedkin di stampo “esotico” mi è piaciuto,nella forma pragmatica e rigorosa,una regia molto personale e diretta che difetta solo nell’approfondimento dei personaggi e del loro rapporto.Ma non stiamo qui a cercare il pelo nell’uovo,film come questo è cinema “maschio” dove conta il vigore nudo e realistico della storia,qui la psicologia non fa la differenza,la sopravvivenza è affidata ad un ingegno “animale”,al vigore fisico,quello che Friedkin riesce a ritrarre in un alchimia anafettiva tra le quattro figure. Cinema d’intrattenimento di altri tempi,dove la location ci trasportava nell’inferno dei personaggi,quando la chimica della storia era pura e naturale e senza un inutile “artefazione”, Friedkin era forse il massimo rappresentante del cinema duro e crudo e il recente “Killer Joe” lo ha dimostrato in modo esaltante.
Duro e crudo (e bellissimo), anche l’altro film dal passato: “Le mani sulla città”, firmato da Francesco Rosi (sua la scenegiatura con Raffaele La Capria), uscito nel 1962, mandato da Rai Movie in contemporanea a Venezia, ieri sera, che Jean Gili ne L’Enciclopedia Treccani di Cinema, nel 2004, descrive come un lucido racconto alla luce del sole sugli ingranaggi dei giochi di potere, che pone il problema dei rapporti tra morale e politica e ci dimostra che l’esercizio del potere, se praticato senza controllo, conduce a ogni genere di abuso e trasforma il cittadino in schiavo, creando così fortune colossali attraverso la trasformazione di terreni agricoli delle periferie in foreste di cemento, devastando il centro della città, sostituendo le case antiche con ignobili edifici che sconvolgono il tessuto urbano e costringono le classi più disagiate a trasferirsi.
Sostenuto dall’interpretazione espressionista di Rod Steiger e di Guido Alberti, dalla fotografia di Gianni Di Venanzo, che crea un clima opprimente attraverso l’uso di un bianco e nero fortemente contrastato, e dalla musica dalle sonorità metalliche di Piero Piccioni, Rosi trasforma il proprio film in una sorta di thriller politico. La sua messa in scena, lungi dall’essere una semplice ricostruzione documentaria, utilizza tutte le risorse dell’immaginario urbano. Napoli acquista così un’autonomia e una ricchezza figurativa capaci di trasformarla nell’emblema di tutte le metropoli occidentali colpite dal dramma della speculazione immobiliare. Il film vinse il Leone d’oro al Festival di Venezia nel 1963 e, fosse stato in concorso, avrebbe vinto anche questo.
Delusione per gli altri film fin’ora presentati e per il forfait di Lindsay Lohan, con il pubblico non convinto dall’opera prima di Emma Dante “Via Castellana Bandiera”, che è apparsa pretenziosa e riuscita solo in parte e da “Tracks”, dell’australiano John Curran, sequela di racconti a sfondo naturalistico; e decisamente annoiato dal rigoroso, ma pesantissimo: “The Police Officer’s Wife”, di Philip Gröning, che ha messo davvero a dura prova l’intera sala Darsena, con tante idee che sono defezioni in corso d’opera, in un un film che scoraggia in ogni modo.
Applausi scroscianti, invece, per Edgar Reitz ed il cast dell’ultimo tassello della sua epopea lungo la storia della Germania, ossia Die Andere Heimat: 230 minuti che appagano mentre raccontano una parabola generazionale, stavolta ambientata a metà ‘800, che sa farci entrare nei delicati equilibri dei suoi personaggi, come sempre vivi, credibili.
Nato a Morbach, in Germania, nel 1932, Edgar Reitz, inizialmente legato ad Alexander Kluge e all’avvio dello Junger Deutscher Film, colse subito un prestigioso riconoscimento con Mahlzeiten, che nel 1967 vinse il Leone d’argento come migliore opera prima alla Mostra del cinema di Venezia.
Reitz si è affermato a livello internazionale con tre lunghi film, notevoli per la qualità della scrittura cinematografica, con una riuscita alternanza di bianco e nero e colore, e per il sapiente intreccio di vicende individuali e storia collettiva: Heimat. Eine deutsche Chronik (1984, 16 ore di proiezione), in cui adotta il modello seriale televisivo per raccontare, con eccezionale vigore epico, la saga dei Simon, una famiglia contadina tedesca, dalla fine della prima guerra mondiale agli anni Ottanta; Die zweite Heimat. Cronik einer Jugend (1992, 26 ore), che riprende le vicende del giovane Hermann Simon negli anni della sua formazione artistica e intellettuale, fornendo un coinvolgente affresco generazionale degli anni Sessanta e Settanta; e Heimat 3. Chronik einer Zeitenwende (2004, 12 ore) ambientato nell’ultimo decennio del sec. 20°, dalla caduta del muro di Berlino al 2000. La trilogia è stata seguita da un film conclusivo, Heimat-Fragmente. Die Frauen (2006). Ha realizzato inoltre il documentario Die Nacht der Regisseure (1995), montaggio di interviste ad autori del cinema.
Mi ha deluso anche la madrina del Festival, Eva Riccobono, trent’anni, alta 1.80 per 57 chili di peso e 40 di scarpe, ex modella, vincolata al solito clichè (che aveva detto avrebbe infranto), della donna algida e seriosa, che ricorda non le movenze delle grandi star nostrane ma le fanciulle longilinee, rosate e ammiccanti, con faccine naîves e curiosi cappelloni, ritratte (con veli tanto trasparenti da mostrare i singoli peli pubici) da Lucas Granch, adatte magari al nord Europa, ma lontane annui luce dalle Veneri nostrane, morbide e sensuali e senza nessuna vocazione luterana di sdoganare il peccato, perché è proprio il peccato, come diceva Carmelo Bene, a rendere le donne più belle.
(116)