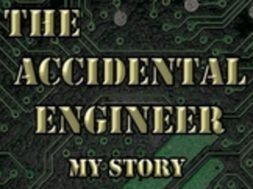(Di Carlo Di Stanislao) Rischiano di essere offuscati dalle corazzate in giro per le sale (il film di Tarantino, la visione burtoniana della “Creatura” di Frankenstein, l’opera cristianofobica e new age di Tim Tylker e dei fratelli Wachowski, i nostri Tornatore e Muccino, l’horror demenziale “Ghost Movie” ) e da quelle di prossima uscita (“Les Miserables” di Tom Hooper), pur essendo due splenditi film, due capolavori fatti di professionalità ed ispirazione, testimoni di un cinema non strillato e senza grandi costi, oggi sempre più difficile da trovare.
Tutto è magnifico in “Quartet”, esordio (a 75 anni) alla regia di Dustin Hoffman e poetica rappresentazione della vecchiaia, storia ambientata in una casa di riposo per musicisti, tratto da una pièce di Ronald Harwood, ispirata a sua volta da un documentario di Daniel Schmid, “Il bacio di Tosca” (1984), girato nella Casa di riposo per musicisti fondata a Milano nel 1896 da Giuseppe Verdi.
Da questo impianto nasce la meravigliosa ed inesistente Beecham House: un trionfo di carte da parati, mobili di gusto e pavimenti lucenti, con uno splendido parco che circonda la tenuta, dove vitalissimi ospiti vivono un declino ancora fitto di ripicche, desideri, velleità, come da ragazzi (Beecham House è in cattive acque e per finanziarla gli ex-artisti vogliono allestire uno spettacolo, con le difficoltà e i capricci che si possono immaginare vista l’età e l’eterogeneità di gusti e talenti).
E si racconta una storia delicata e splendida, con personaggi (veri musicisti in pensione) con abiti e chiome curate, espressioni ben disegnate, che dimostrano come non sia un delitto estetizzare la senilità.
In questo splendida, incredibile opera-prima, Hoffman gioca a carte scoperte, mobilita un coro di volti e corpi che da soli varrebbero il film, intreccia senza una sola stecca opera e operette, romanze e canzonette, tutto in nome del cinema che mostra non la vita com’è ma come dovrebbe essere.
Oltre tutto, oltre alla regia accurata e concentrata sulle recitazione, con una Maggie Smith certamente da Oscar (sarebbe il terzo), altro punto di forza del film è la colonna sonora, costellata di capolavori di Verdi, Bach, Boccherini, Haydn, Rossini, ad intrecciarsi con una narrazione sempre lieve ed ispirata in ogni singola parte.
Fra tutti, indimenticabili sono i personaggi di Wilf e Sissi: il primo che è un amabile vecchio sporcaccione, che – a dire suo, ma non degli altri – ama corteggiare le donne di qualsiasi età e ha qualche problema a censurarsi; ha la battuta sempre pronta e la capacità di sdrammatizzare in ogni circostanza.
Lei invece, l’ineffabile Sissi, ha qualche problema con la memoria e col passato , ma conserva un candore ed un entusiasmo che sono disarmanti.
La sceneggiatura, soprattutto nel caso di questi due personaggi, è frizzante e strappa sorrisi e risate, ma anche attenti e non pedanti momenti di riflessioni su temi complessi come la senilità e l’arte, con una regia che ci dimostra come quest’ultima è sempre una questione di stile: laddove c’e’ l’essere e il saper fare, c’è qualcosa di diverso da una semplice buona produzione.
L’altro bel film che rischia di passare inosservato o quasi, è “Flight” di Robert Zemeckis, con Denzel Washington, Don Cheadle e Kelly Reilly, storia di un pilota alcolizzato che, con una manovra azzardata e riuscita, dopo un cedimento dell’aereo, salva novanta passeggeri, ma ne perde sei.
Eroe per la stampa e per l’opinione pubblica, l’intrepido pilota deve però vedersela con la NTSB (National Transportation Safety Board) e s da una parte le indagini rivelano la causa meccanica che ha provocato la tragedia, dall’altra tradiscono il segreto indicibile di Whip Whitaker: l’alcolismo. In attesa del processo, Whip incontrerà Nicole, una tossicodipendente con cui condivide il dramma della dipendenza nell’abisso in cui lo ha precipitato il suo volo, non si vedono uscite di emergenza, né manovre spericolate e vincenti.
Pellicola coraggiosa e che critica, ferocemente e fino in fondo (come hanno fatto negli ultimo tempi Nolan e Anderson, ad esempio), le ossessioni tipiche dello stile di vita americano. Stile di vita che ha bisogno di eroi e di colpevoli, provocando un divario sempre più incolmabile tra chi arriva in cima e chi resta a guardare. Il leader nero di un aeromobile in avaria, tanto eroico quanto colpevole, interpreta forse il tempo problematico di una nazione che ha vissuto gli ultimi quindici anni come il protagonista al di sopra delle proprie possibilità., con 11 settembre, guerra al terrore, crisi economica e finanziaria, che hanno collassato il Paese e arrestato il ‘volo’, insinuando la paura nel suo orizzonte politico e psicologico.
Ma dopo l’apocalisse una ‘seconda possibilità’ è pensabile dentro uno sguardo (di una bambina e di una donna che ha salvato un bambino) e attraverso un atto di responsabilità individuale che diventa collettivo.
Comunque, come notano Morandini & Co., Zemeckis non assolve nessuno, tantomeno il suo (im)pavido pilota, partecipando alla sua sofferenza ma ponendolo davanti al buco nero della sua colpa. Nel modo di Wilson (il pilota), il pallone affettivamente risemantizzato da Tom Hanks sull’isola di Cast Away, una piccola (e smisurata) bottiglia di vodka diventa un vero personaggio, unica e insidiosa forma di relazionalità ancora possibile nella solitudine di una vita bruciata. Wilson e la bottiglia sono amici-nemici immaginari, simulacri di una socialità diversamente perduta, residuo bisogno di un legame, di una ‘dipendenza’ (affettiva/alcolica) che cerca e trova per entrambi un’indipendenza. Indipendenza che abbatte l’idolo e libera dalla ‘prigionia’.
“Flight” segna il ritorno al cinema di Robert Zemeckis, un ritorno volutamente in tono minore, per il regista della trilogia di Ritorno al futuro, focalizzato sulla dipendenza, racconto 13 anni dopo “Cast Away” di un’altra solitudine, confezionato in modo pulito, equilibrato, asciutto e convincente.
Candidato a due Oscar (per il miglior attore protagonista e per la migliore sceneggiatura originale), il film ha il suo punto di forza aggiuntivo nella interpretazione di Washington (notevole la scena in cui dialoga con Kelly Reilly e James Badge Dale sulle scale di sicurezza dell’ospedale), più il cammeo di John Goodman, nei panni di uno spacciatore fuori di testa.
In fondo sia Hoffman che Zemeckis ci raccontano, con timbri diversi, la stessa cosa: restare soli, a qualsiasi età, significa calarsi in un inferno.
E viene voglia di rileggersi (col cinema vero è sempre così: si aprono molte porte, una dopo l’altra, siche la durata dello spettacolo è infinita), “La solitudine de l’anima” di Eugenio Borgna, pubblicato da Einaudi due anni or sono, dove si argomenta e si riflette sulle molte forme di solitudine, quella interiore che è fonte di conoscenza di sé e meditazione, solitudine creatrice e positiva in cui si cela una domanda di serenità e di speranza e quella dolorosa, negativa, che isola e separa dal mondo, una solitudine che si genera nella malattia, nel dolore dell’anima e del corpo, nella perdita della speranza.
E ci vengono in mente, in un gioco di rimandi e richiami, le parole dolorose di Anaïs Nin: “ Ho pianto perché non posso più credere e io amo credere. Posso ancora amare appassionatamente Ho pianto perché il processo grazie al quale sono divenuta donna è stato doloroso. Ho pianto perché non sono più una bambina con la fede cieca di una bambina. Ho pianto perché i miei occhi sono aperti sulla realtà anche senza credere. Questo significa che amo umanamente. Ho pianto perché d’ora in avanti piangerò meno.
Ho pianto perché ho perso il mio dolore e non sono ancora abituata alla sua assenza”.
Infine, abbiamo voglia di rivedere i grandi film che di solitudini hanno parlato: “Ivan il terribile”, “Umberto D”, “Europa 51”, “Il gusto del sakè”, “il posto delle fragole”, “Taxi driver”, “Un uomo da marciapiede”, “Sacrificio”, “Le lacrime amare di Petra von Kant”, “Film blu”, “The burning plain-Il confine della solitudine”, “ACAB” ed altri ancora, tranne “La solitudine dei numeri primi”, un brutto film da un libro invece magnifico, svilito (capita al cinema), da una errata scelta di diluire la rappresentazione dei traumi di Alice e Mattia saltellando di continuo da un flashback all’altro, con una trama che ne esce completamente destrutturata, e, sostanzialmente, dissolta, cosa che i veri autori sanno accuratamente evitare.
(93)