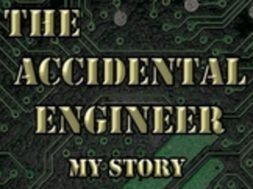(di Carlo Di Stanislao) – Ciò che scrive su l’Espresso di questa settimana Mario Fortunato, cioè che siamo abituati ad una pessima letteratura, mi pare esagerato, ma certo a leggere i “Diari” di John Cheever, pubblicati da Feltrinelli col titolo: “Una specie di solitudine”, nella bella traduzione di Adelaidi Cioni, ci si rende conto di cosa sia sommamente lo scrivere. John Cheever ha scritto i suoi diari dalla fine degli anni quaranta sino alla sua morte, avvenuta nel 1982, mettendoci dentro i fatti per non mascherare nulla e raccontare, con stile sublime, dei dolori e delle felicità, della goffagine sessuale, dello scoramento e, talvolta, della disperazione. Era un uomo pieno di contraddizioni Cheever, un uomo che amava la moglie e i figli, ma si sentiva profondamente solo; amava le donne, ma amava anche gli uomini; si odiava perché aveva il vizio di bere, ma per gran parte della vita non riuscì a smettere; era un grande scrittore, ma la sua sensibilità era così pronunciata da limitarlo come persona. In queste pagine ci è data la possibilità di seguirlo in un dialogo serrato con se stesso, di starlo ad ascoltare mentre cerca di capire e registrare le infinite variazioni della luce e del suo intimo sentire. Qui la scrittura è totalmente libera, folgorante, una fonte inesauribile di poesia e di struggenti considerazioni sulla natura dell’amore, del sesso, del desiderio e della vita. Nella sua estrema peculiarità, Una specie di solitudine si presenta come un diario d’emozioni, di follia lucida ed espressiva, di considerazioni personali che vanno ben oltre un semplice taccuino di pensieri, ma che divengono – per certi aspetti – quasi una saga familiare incompiuta, risvolti spesso drammatici di un’esistenza in bilico fra l’apparenza educata e decorosa contrapposta alla violenza interna, alla corruzione d’animo e di pensiero che logora sé stessi e la propria essenza. John Cheever (Quincy, Massachusetts, 1912 – Ossining, New York, 1982) è ampiamente considerato come uno dei massimi scrittori americani del Novecento. Vincitore del premio Pulitzer con I racconti (1979), ebbe molto successo anche cimentandosi nel romanzo con capolavori come Cronache della famiglia Wapshot (1957), Bullet Park (1969) e Falconer(1977). I suoi taglienti ritratti della borghesia americana sono stati ispirazione per una generazione di scrittori, registi ed artisti visivi. Il libro pubblicato da Feltrinelli è di 500 pagine e costa 20 euro. Ora una riflessione. Mi son sempre chiesto perché Cheever non abbia avuto in Italia grande popolarità. Dalle traduzioni di Pavese e Vittorini, al prezioso lavoro di Fernanda Pivano, nessun mercato letterario è stato più aperto del nostro ai libri Usa. Perfino i minimalisti, McInerney, Janowitz, Minot, Leavitt sono stati accolti con generosità. Parecchi scrittori italiani contemporanei sono così “nutriti” di narrativa americana che la loro prosa suona spesso “traduzione yankee”. Ma l’entusiasmo non include Cheever. Comunque, sempre Feltrinelli, ha pubblicato, a giugno, anche “I racconti” di Cheever: un volume di 850 pagine al prezzo di 40 euro, che, assieme ai diari, dovrebbero stare in ogni libreria. Nelle pagine di Cheever, soprattutto nei “racconti” e nei “diari”, si ritrova l’amore per l’essere umano che palpitava dentro Flannery O’Connor, nei suoi racconti si beve la stessa quantità di gin delle short stories di Fitzgerald e i suoi protagonisti potrebbero benissimo essere i vicini di casa dei personaggi di Raymond Carver. Eppure, John Cheever ha una voce inconfondibile, si riconosce la sua firma in ogni singola frase. La sua straordinaria sensibilità – prima umana e poi letteraria – non permette di paragonarlo ad altri scrittori statunitensi. Maestro del racconto come misura ideale di investigazione e reinvenzione, Cheever è stato il riconosciuto testimone di un’America suburbana soffice e torbida, e continua a essere l’implacabile voce-sonda che ha per la prima volta tratto dall’ombra la gestualità rituale e le emozioni malate di una media borghesia chiusa dentro il suo severo protettivo benessere. Piccole anime, piccoli accadimenti, piccole trame, e un grande disegno che le contiene. La “commedia umana” di John Cheever è contenuta in questi sessantuno racconti che costituiscono la dorsale più riconoscibile e più fascinosa della sua produzione. Dagli anni Sessanta in avanti l’editoria italiana ha cercato di trovare un posto di eccellenza a questo scrittore, a volte puntando sui romanzi a volte sbriciolando i racconti in piccole raccolte: in questa edizione vogliamo essere vicini alla densità, alla complessità ma anche alla naturale fluvialità di una narrazione che chiede continuità e costanza. Fatto com’è di insistenze e ossessioni, il mondo di John Cheever si dispiega qui intero e avvolgente. Si dà conto, per la prima volta in Italia, della galleria di personaggi che Cheever ha saputo creare e dello stile che ne regge la sequenza. Cheever è stato definito il Cechov d’America, un Checov di periferia, i cui punti di riferimento erano Updike, Malamud e Bellow. Nei suoi racconti e romanzi è come se guidasse l’automobile lungo i sonnacchiosi viali di anonime province, fino a fermarsi dove una luce indica che in mezzo a tutto quel paradiso di giardini curati e scintillanti, e di elettrodomestici che governano il perfetto andamento delle faccende quotidiane, ci fosse una crepa, e lui decidesse di fermarsi lì, per guardare dentro le finestre e dimostrare al mondo intero che anche nella più ordinaria e noiosa delle vite scorre senza scampo una vita vera. Tornando ai suoi “Diari” (questo il titolo originale dell’opera che in italiano suona “Una specie di solitudine”), sono uno dei libri più straordinari del XX secolo, testimonianza di vita, gioie e tormenti di un artista capace di vivere i sentimenti da uomo comune, l’individuo semplice celebrato dal musicista americano Aaron Copland nella Fanfara per l’uomo comune, composta proprio mentre il giovane Cheever è in divisa militare durante la guerra. L’occhio raffinato dello scrittore può allontanarlo dalla gente semplice, Cheever è invece unico nel restituirvi, come Cechov, la sensazione che non esistano normalità, banalità, routine, che ogni singolo istante della nostra vita sia unico, prezioso, eterno, purché “esaminato”, come chiedeva il filosofo Nozick nel saggio The examined life o come ha fatto David Lynch nella più parte dei suoi film migliori. Cheever canta in chiesa da puritano yankee e ci fa sentire l’odore dei fiori, l’emozione della fede, il conforto del rito. Poi, d’improvviso, la curva nella sagoma di una donna, il respiro del fiato di un vicino, rompe la grazia dell’incanto e l’inferno della vita quotidiana inghiotte l’autore. “Oh, che Paradiso sembrava” si intitola una delle ultime novelle (anche questa tradotta in italiano, chissà mai perché, “Sembrava proprio di stare in paradiso”) e l’illusione dell’Eden, opposta all’orrore del nulla, accompagna Cheever in ogni riga. Quando l’alcol lo riduce alla demenza, se ne riscatta, con coraggio e umiltà stoiche, agli Alcolisti Anonimi. L’amore omosessuale, di cui si vergogna da giovane nei conformisti anni ’50 e che in qualche modo accetta prima di morire, gli impone di recitare nei salotti la parte del gentleman del New England, giacche di tweed e pullover Shetland giro collo, mentre occhieggia ai bagni pubblici sconosciuti o desidera passanti frettolosi. Tormenta la moglie Mary con frenesie sessuali e alcolismo, ma si sente a sua volta avvilito tra indifferenze e sarcasmi: eppure non divorzia, perché, scrive in un racconto, “i John e le Mary non divorziano mai”, la proclama “mia prima, gentile, moglie”. La figlia Susan, che spesso umilia a tavola sbronzo, diventa scrittrice e ricorda il padre nelle struggenti memorie, Home before dark, A casa prima del buio. John Cheever e la figlia scherzavano, proponendosi l’un altro titoli e quando a Susan viene in mente Home before dark, Cheever conclude “Bellissimo, ma lo userò io”. Non farà in tempo per un cancro, ma amava quel titolo che include la polarità magica dei Diari. “Casa” è il mondo degli affetti, l’amore, i cani adorati, gli amici con cui giocare a backgammon, il drink allegro che non è ancora droga, la letteratura che, come scrive nell’ultimo saggio, “può salvare il mondo”, la stima dei colleghi, Bellow, Updike. Il “Buio”, da cui bisogna affrettarsi tornare, è la lussuria cieca, odio non amore, l’impotenza sessuale che Cheever descrive brutale, l’alcolismo, la pagina bianca da riempire e che sgomenta, la depressione. Come il diarista tedesco Victor Klemperer, ultimo ebreo a Berlino durante il nazismo che registra ogni violenza, ogni umiliazione, ogni schiaffo degli oppressori, Cheever annota la gioia di pattinare sul ghiaccio, la felicità di falciare l’erba con il figlio (“sono l’ultimo gentleman che sappia imbracciare una falce”), l‘amante fuggevole a Manhattan, la bottiglia di gin nascosta e ricercata, il tanfo della stanzetta dove si nasconde, provando a insegnare al college, il terrore di disperdere per sempre il talento. Leggere i “Diari” di Cheever è incontrare un amico colto e franco, un Montaigne nostro contemporaneo, che guida l’auto, telefona, guarda la tv, ma che al contrario del saggio francese sa disperarsi e penare come noi. Nei giorni di gioia sarà per voi voce allegra, nelle ore cupe una mano – sia pur tremante per i Martini – di incoraggiamento, fratello provato dal destino ma emerso dalla pena incurvato e integro.
(122)